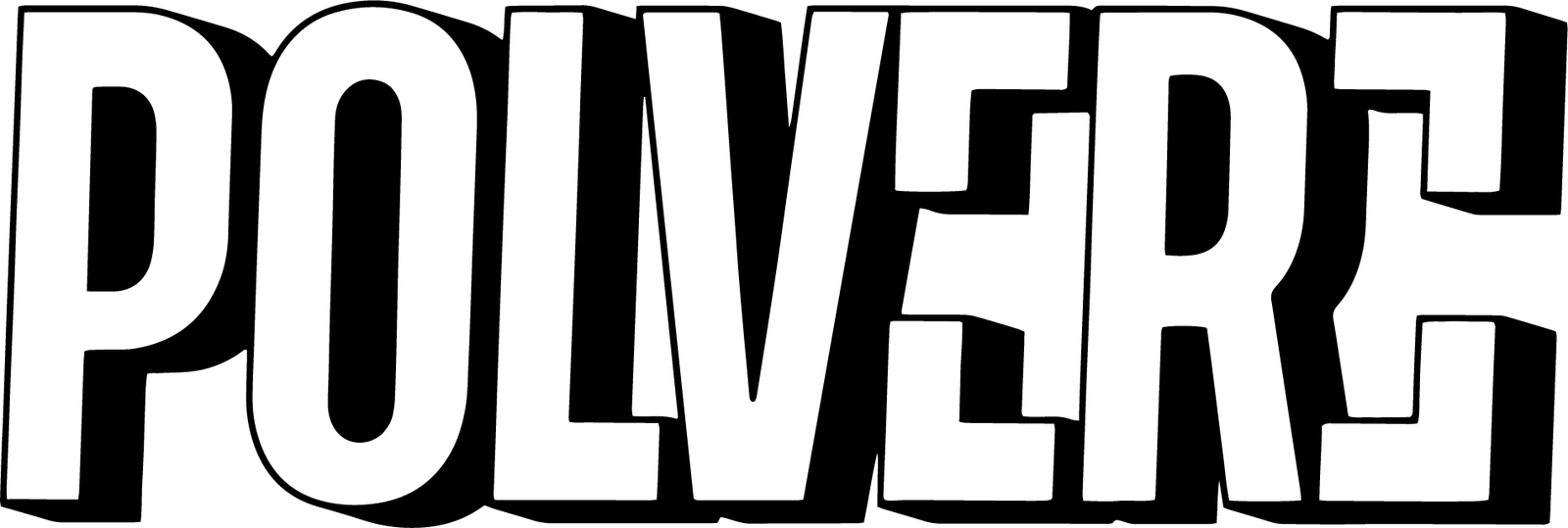«Ai festival devi arrivare all’inizio per vedere le cose fighe», dice la mia amica Clara che saggiamente è entrata al Bunker di buon’ora. Spesso è così. Io aggiungerei anche che devi arrivare all’inizio per trovare l’atmosfera più bella, quando ci sono poche persone, i più entusiasti e interessati. Al Jazz Is Dead! se ti presenti presto fai un affare: hai la certezza di entrare anche se non hai prenotato il biglietto, non trovi molta coda, e ti godi tutta la musica live della giornata. È la rivincita dei puntuali, degli ansiosi, degli impazienti; se non rientri in almeno una di queste tre categorie allora hai qualcosa da nascondere.
Ma anche i puntuali ansiosi impazienti steccano: io riesco ad arrivare solo nel tardo pomeriggio, quando il pubblico sta ancora commentando la voce ammaliante di Cindy Pooch, che li ha completamente ammutoliti, se non nel momento in cui li ha fatti cantare per accompagnare la sua voce. Per la francese cresciuta in Camerun è la prima esibizione in Italia; inaugura una serata che segue il filo conduttore dell’Africa, coi suoi suoni caldi e ritmi ipnotici declinati in tutti i generi: dall’afro beat all’elettronica, dal rap al — ovviamente — jazz.
Il viaggio in Africa continua con Le Cri du Caire, progetto nato dal poeta e cantante egiziano Abdullah Miniawy: il suo canto in arabo tocca le corde più profonde, senza bisogno di comprenderlo. Ma ci provo lo stesso: mi piace pensare che Caire (Il Cairo, capitale egiziana) funga da assonanza per cœur (cuore), dunque “il grido del cuore”. Esibizione emozionante, anche per la stessa band, formata da violoncellista e sassofonista. Il live è in collaborazione con il Torino Jazz Festival, con il quale c’è un’usuale collaborazione, come accaduto con il concerto di John Zorn di un mese fa.
Dave Okumu & The 7 Generations è il set che può essere considerato più “tradizionale”, con band di approccio chitarristico che spazia dal funk al dub, con intermezzi strumentali jazz. Il musicista nato in Austria, ma di origini keniote, ha suonato per Amy Winehouse, St. Vincent, Jane Birkin, Tony Allen. È il primo momento in cui si balla, si continuerà senz’altro anche dopo. Svampe di verdura nell’aria. La sera scende, “blue hour” direbbero i fotografi.
Proprio i fotografi sono i miei compagni preferiti di chiacchiere nei momenti di pausa: il mio selfie-ricordo della serata è con Martina Caratozzolo e Fabio Serrao. Più tardi apparirà anche Loris Brunello appena arrivato dal concerto dei Thirty Seconds To Mars all’Inalpi Arena, ah già oggi c’era pure quello. Trovo in ottima posizione in transenna Alessandro Bianco che racconterà su Polvere la serata di domani, “quella con Daniela Pes“. Tra un live e l’altro il direttore artistico Alessandro Gambo presenta i musicisti che si avvicendano sul palco: è ormai il momento dell’attrazione principale della serata.

Ecco gli I Hate My Village, nati dalla passione di Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion) e Fabio Rondanini (Calibro 35) per la musica africana, ai quali si sono aggiunti Marco Fasolo (Jennifer Gentle) e Alberto Ferrari (Verdena). Ormai sono una realtà consolidata; i fan di Viterbini non sanno se preferire BSBE o IHMV — io la risolverei così: i primi per gli assoli, i secondi per i riff. Il secondo album è uscito da qualche giorno, il tour è appena all’inizio, la recensione è già su Polvere. Alberto Ferrari emana l’aura umorale che ti tiene in sospeso per un imprevisto che sembra sempre dietro l’angolo, anche quando non accade mai. Un drone vola nel cielo schiarito dalla luna piena, una telecamera in transenna registra i concerti: chissà se, dove e quando potremo rivedere tutti gli artisti di oggi.
L’esplosione finale del palco all’aperto è quella di Aunty Rayzor, rapper nigeriana che si mangia il pubblico, incendia le ragazze, invita il pubblico a levarsi le giacche e sventolarle. La temperatura si abbassa ma il suo set fa venire caldo. Finiti i concerti all’aperto, è il momento di clubbare all’interno del Bunker, con DJ Haram, Optimo, Dj Storm. Rimango all’aperto a parlare con persone che incredibilmente non vedevo da una vita: la musica serve anche a questo.
Le vicissitudini dei festival torinesi ci stanno insegnando che è bene conoscere il valore della musica dal vivo e del lavoro di chi la rende possibile. Jazz Is Dead! è realizzato dall’Arci e da Magazzino sul Po, con la direzione artistica e la comunicazione di Tum. È una proposta di musica sperimentale e d’avanguardia che non si trova nei circuiti dei festival tradizionali, ma che ha affermato negli anni una forte identità: il pubblico si fida di Jazz Is Dead!.
È la settima edizione, che ha la dichiarazione d’intenti di essere “perfetta”: per la prima volta c’è un palco all’aperto per ospitare nomi che iniziano a essere di grosso seguito, e per la prima volta c’è un biglietto di ingresso, che comunque è super popolare (10€), ed è bene che ci sia, poiché la musica andrebbe sempre pagata. Le persone possono entrare anche se non sono riuscite a prendere la prevendita, presentandosi sufficientemente in tempo: «il festival non è sold out e non lo sarà mai», si legge sulla comunicazione, un concetto che oggi sembra quasi rivoluzionario.
Per chi vuole anche quest’estate musica “alla Jazz Is Dead” c’è la sezione sperimentale del festival di Piedicavallo dal 16 al 18 agosto, curata sempre da Tum. Un weekend sui monti biellesi, una mini-vacanza musicale, un nuovo appuntamento con il mai visto, il non ancora sentito, il nemmeno immaginato.