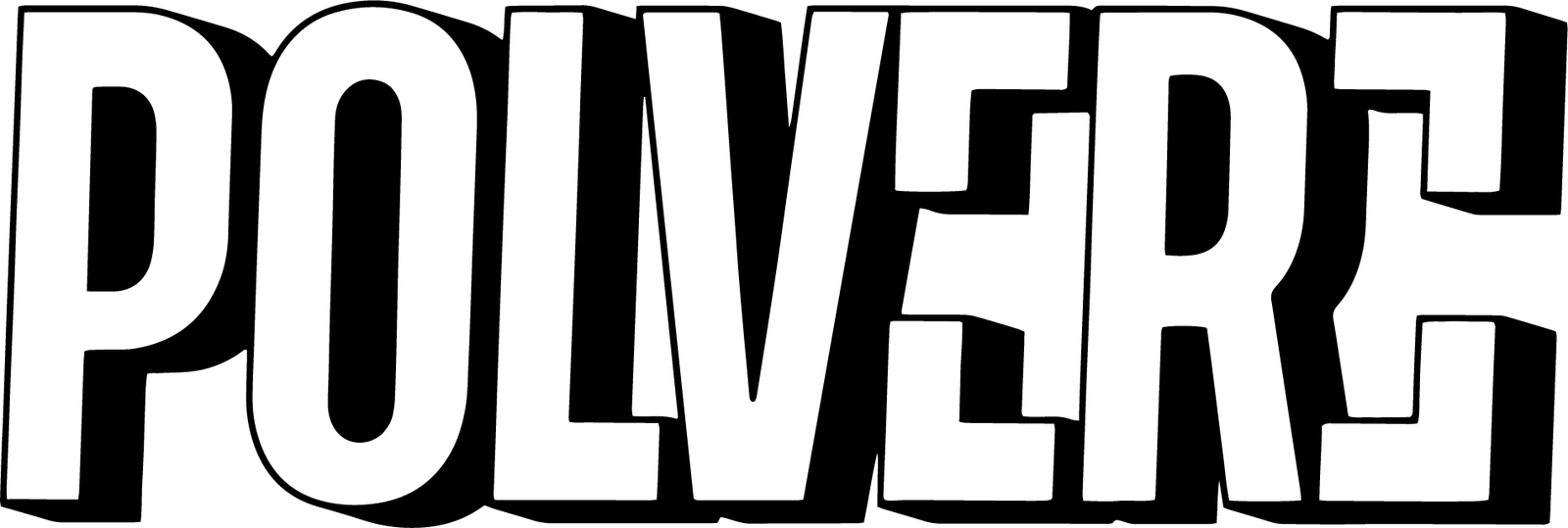L’estetica dei Nouvelle Vague è fatta di continui richiami e di suggestioni evocative. Basti pensare al loro nome – perfetto nell’identificarli –, che già in sé racchiude molte delle chiavi d’interpretazione necessarie a raccontare il gruppo e il progetto di cui questo si fa portavoce.
Nouvelle Vague – letteralmente, “onda nuova” – subito rimanda a un codice estetico ben definito e universamente riconoscibile, costituivo della corrente cinematografica francese che ha rivoluzionato il mondo a partire dalla fine degli anni 50. Ma “onda nuova” è anche new wave, il filone musicale nato alla fine degli anni 70 dalle ceneri del punk e dalla prossimità con il punk-rock, strizzando l’occhio alle convenzioni pop. Infine, Nouvelle Vague traduce anche il portoghese bossa nova, genere musicale brasiliano, caratteristico e peculiare, figlio diretto del samba e di Antônio Carlos Jobim.
Ecco allora spiegato, con un breve viaggio nel tempo e nello spazio, il progetto della band francese: riarrangiare le canzoni celebri della new wave in chiave bossa nova, reinterpretandole però dal punto di vista estetico, ispirandosi ai dettami di François Truffaut e Jean-Luc Godard.
Quando la band arriva sul palco dell’Hiroshima Mon Amour – locale che, neanche a farlo apposta, si incastra perfettamente tra i rimandi cinematografici della band –, l’atmosfera è avvolta dalla nebbia della macchina del fumo. Le sagome dei musicisti si intravedono sullo sfondo: profili eleganti, in giacca o in camicia, arpionano i tasti dei loro strumenti di matrice jazz: una chitarra acustica, un contrabbasso elettrico e una tastiera a 61 tasti – forse non così tanto jazz –, collegata in MIDI a un pc. Sul fianco destro la batteria, disposta su un lato, mischia il drum set convenzionale agli strumenti percussivi a mano.

Sopra le nubi imperiture che avvolgono al scena, le luci singhiozzano come lampioni mezzi fulminati di un vicolo buio della metropoli parigina. Gli accordi in minore e in Maj7, tra seste, none e tredicesime, si confondono nell’aria. Le suggestioni sono così diverse tra di loro; si moltiplicano, attraversano la mente: Gli Aristogatti, La Pantera Rosa, i film onirici di David Lynch. Le due cantanti, protagoniste interpreti di questo show, rallentano la percezione temporale, con movimenti lenti e sensuali, sussurri al microfono e sguardi reciproci di complicità. Ci troviamo, d’un tratto, al Roadhouse di Twin Peaks. L’estetica che accompagna lo show, però, presto cambia (e cambia ancora). Pur mantenendo l’aura di mistero e sogno, volge al festoso e si fa cabaret.
Dal cabaret, però, non si fa più ritorno. Il codice espressivo si cicatrizza e, finalmente, si avverte la sua identità. Il centro della scena, però, resta dinamico: ora affidato al contrabbassista, ora al percussionista. Le due cantanti si rimbalzano i riflettori, seguendo l’alternanza delle proprie cifre stilistiche. Gli artisti cercano spesso il coinvolgimento del pubblico, per stuzzicarne la partecipazione: vogliono farlo cantare, vogliono farlo urlare.
La commistione tra i generi è varia, sotto il dominio perenne del jazz. Non mancano gli approcci reggae, quasi totalizzanti in Shout dei Tears for Fears e in Should I Stay or Shoul I Go? – ma i The Clash, in questo, sembra ci prendano per mano. Però c’è anche il rock, che si fa quasi noise nell’assolo di Too Drunk To Fuck (i Dead Kennedys ringraziano): canzone che, del resto, firma il picco espressivo dell’esibizione, stappata una bottiglia di vino da condividere col pubblico. Ed è qui che, finalmente, la chitarra elettrica si prende il centro della scena.
Dopo un’ora e poco più, sulle note di In a Manner of Speaking, lo spettacolo è finito. Tra suggestioni variopinte, rimandi artistici variegati e linguaggi espressivi eterogenei, viene da chiedersi, alla fine dello show: ma chi sono i Nouvelle Vague?
Sicuramente un progetto riuscito, con un impronta chiara, un’estetica affascinante e una bellissima presenza scenica. La sua identità, però, rimane evanescente, immersa in quello stesso fumo di cui si circondano sul palco. Sarà il trovarsi in mezzo a tante atmosfere differenti, così distinte tra di loro da ostacolare una totale immersione dal punto di vista musicale; sarà che si ha l’impressione di assistere di più – e prima di tutto – a uno spettacolo musicale, piuttosto che a un concerto: ma forse, trattandosi di un gruppo fondato sul riarrangiamento di canzoni cover, è normale sia così.
Qualunque sia il motivo, in fondo, non è poi così importante: fuori dall’Hiroshima – che questa sera è il Moulin Rouge –, il pubblico canta le sue canzoni preferite, riscoperte sotto una luce differente. L’atmosfera è allegra e compiaciuta. Felice, soddisfatta. L’aria di Torino sembra farsi più leggera. La suggestione resta viva oltre i cancelli, lungo i corsi e i controviali. Si torna a casa, con le nubi tra i pensieri: “fino all’ultimo respiro”.