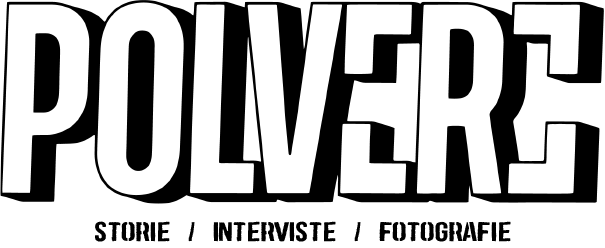Le Salette hanno rappresentato un vero e proprio antidoto all’apatia provinciale per la Generazione Y. Tra la puzza di umido, le chitarre scordate e le birre scadute, decine di ragazzi hanno sputato su un vita fatta di vasche pomeridiane, calcetto il mercoledì sera e ottimo rendimento scolastico
Una delle mie prime significative esperienze in una saletta prove è stata nel lontano 2006 quando, insieme ad alcuni compagni di scuola, mettemmo su un gruppo chiamato Palombaros. Avevamo compiuto da poco 16 anni (o forse nemmeno), ascoltavamo un sacco di musica, eravamo fissati con i B-Movie e suonavamo le cover dei Motörhead, degli MC5 e di GG Allin.
Il fatto di avere un luogo in cui passare i pomeriggi bevendo birre del discount, fumando hashish scadente e sbraitando dentro un microfono frasi che invitavano a baciarci il culo mentre qualcuno beveva il nostro sperma, ci ha insegnato un approccio alla vita che non si impara sui banchi di scuola. Ma soprattutto, ha fornito una via di fuga a tutti quegli adolescenti che, come noi, avrebbero voluto passare i pomeriggi con Jay e Silent Bob spaccando la testa a Step e Babi.
Se sei cresciuto in provincia e hai avuto la folle fortuna di innamorarti della musica underground, molto spesso la saletta è una delle poche oasi in mezzo a quell’insopportabile deserto rappresentato dall’apatia, dall’arrivismo, dalle vasche in centro e dal giropizza del sabato sera. Perché quelle stanzette piccole, maleodoranti, mal insonorizzate e disordinate, non hanno solamente ospitato generazioni di city rockers animati da velleitarie aspirazioni musicali. Quelle stanzette buie hanno infatti partorito un vero e proprio ecosistema composto da strimpellatori smaniosi, disagiati in cerca di autore, spaccini, tossici, militanti disillusi e anonimi viandanti alla ricerca di un’alternativa serale. Un milieu dannato in cui, per anni, si sono consumate cover di dubbio gusto, litigate feroci, scopate su divani lerci, dibattiti esistenzialisti dal sapore psichedelico e leggendari Secret Show organizzati da un giorno all’altro.
El Barrio. La filosofia del Do It Yourself.
Nonostante il nome possa trarre in inganno, “El Barrio” era una minuscola saletta, inaugurata nel 2007, all’interno di un Centro sociale autogestito e utilizzata in precedenza come deposito per vari materiali. In origine, l’accesso a “El Barrio” era sbarrato a chi non frequentava i corsi di batteria e di percussioni per mezzo di uno spesso catenaccio, che blindava la porta d’entrata. Ma, nel giro di qualche mese, riuscimmo ― anche grazie al nostro impegno militante ― ad avere le chiavi della sala. Era il periodo delle bretelle, dei capelli rasati a zero e delle nottate passate su eMule a scaricare discografie di gruppi Oi! improponibili: possedere quello stanzino ci faceva sentire parte di un qualcosa che sembrava sempre troppo lontano da noi. Non avevamo i “vecchi” della scena, né, tantomeno, i concerti fighi che bramavamo dalle altre città; ma avevamo “El Barrio”, il nostro Barrio. Tra discussioni interminabili sull’origine del movimento skinhead e accordi distorti accompagnati da aritmici tupa-tupa, si sono create amicizie, amori e antipatie che hanno segnato la nostra adolescenza provinciale.
La filosofia del D.I.Y. è stata, per quasi due anni, il cuore della saletta: le (poche) conoscenze musicali di ognuno venivano messe a disposizione della collettività. Chiunque, con una dose di buona volontà, un pizzico di pazienza e qualche lattina di birra, poteva imparare a strimpellare uno strumento in modo completamente gratuito ma anche totalmente casuale. Come in una roulette russa, dentro “El Barrio” potevi trovare il compagno di scuola metallaro che ti insegnava l’attacco di Raining Blood degli Slayer, ma anche la hippie quarantenne amante dei bonghi e dei tamburelli gitani. Stili, attitudini e culture che si mescolavano tra di loro dando vita a un prodotto ibrido e, molto spesso, difficile da comprendere. Una volta, ad esempio, rischiai addirittura di partecipare a una sorta di battaglia della band, suonando in playback con un gruppo pop-rock locale il cui cantante era soprannominato “Guido Gesù” a causa della netta somiglianza con il messia. Il batterista si era spaccato un braccio e, vista l’indisponibilità degli altri sostituti, mi ritrovai a passare un pomeriggio in saletta fingendo di suonare la batteria davanti allo sguardo impensierito di Guido Gesù. Inutile dire che non partecipai al live: lo shuffle jazz-rock non era proprio il mio forte.
Skinheads, punk, hippie, schizzati di ogni genere, tamarri e discotecari che condividevano una strana amicizia o la passione per la musica. O la passione per le droghe. E, in alcuni casi, tutte e tre le cose insieme. “El Barrio” era molto di più di una sala prove, era una parte di mondo che avremmo sempre voluto conservare. Perché per noi, come dice un bellissimo film, dentro quel posto «c’era molto più amore… tipo arghh!». E questo non ce lo poteva togliere nessuno.
Il Tempio. Quella volta del secret show.
A differenza di “El Barrio”, il “Tempio” o “Tempietto”, è una struttura costruita realmente a forma di tempio. Una vera e propria cafonata ideata da qualche architetto reazionario che, però ― per la fortuna di molti punkrockers locali ― era stata riconvertita a sala prove. La politica del Tempio era molto semplice: chiunque poteva affittare a trecento euro mensili uno dei 6 fondi presenti nelle cantine della struttura diventandone proprietario temporaneo per un anno. Chiaramente, una volta presa in affitto la stanzetta, si poteva usufruire del locale ventiquattr’ore su ventiquattro. Questo incredibile vantaggio trasformò le salette in uno dei più incredibili ritrovi del nightclubbing della provincia underground. A seconda degli affittuari, infatti, al Tempio si poteva chiacchierare fumando una canna e ascoltando musica chill, si poteva suonare Black Metal alle quattro del mattino, si poteva giocare a poker e pure fumare le bottiglie seduti sullo sgabello della batteria.
Nel 2014, al Tempio venne organizzato un secret show da un collettivo della scena hardcore locale. Organizzare un concerto hardcore in una sala di pochi metri quadrati era una roba da pazzi. Organizzarlo con gruppi provenienti da altre regioni, era una roba da fuori di testa. Tra gli eccessi collettivi, il nervosismo dei vari straight edge e le pisciate sui muri e la gente collassata sul pavimento del corridoio che portava alle salette, ci fu anche una rissa sfiorata tra locals e gruppi ospiti. Nel bel mezzo della serata, infatti, il cantante dei Guasto, gruppo leggenda dell’hardcore locale, nonché co-organizzatore dell’evento, cominciò improvvisamente a minacciare alcuni romani presenti al concerto. Il motivo delle minacce non è tuttora chiaro: il soggetto in questione ha nuovamente confermato, qualche giorno fa, di non ricordarsi assolutamente la causa del litigio. Forse i romani non sapevano suonare bene, forse sapevano suonare troppo bene o forse, più semplicemente, erano romani. Chiaramente, la cosa non rovinò l’evento ma anzi, lo rese ancora più leggendario: uno dei nostri ― in camicia hawaiana, “Punx” tatuato sulle dita della mano destra e cappellino con le borchie ― che minaccia gente a caso scimmiottandone la parlata, faceva sicuramente molto hardcore.
Scene di questo tipo sono state ordinaria amministrazione all’interno del “Tempio” che oggi, purtroppo, si è trasformato in una banalissima casa vacanze in cui turisti milanesi e tedeschi possono dar sfogo alla propria voglia di lusso, nuotando in una piscina illuminata al neon e osservando ― compiaciuti ― quella terribile struttura.
Per citare una bellissima canzone di Caterina Caselli, le salette prove, nella loro brutale interezza, sono state il nostro «volto della vita». No: là dentro non abbiamo imparato a suonare, non siamo diventati delle rockstar e non siamo riusciti a vivere di musica. Là dentro, però, tra chitarre scordate e muri ammuffiti, abbiamo costruito un pezzo della nostra vita. Un pezzo veloce, distorto, rozzo e, forse, pure suonato male. Ma è un pezzo che ci porteremo dentro per sempre. Ed è grazie a quello che, ancora oggi, passati i trent’anni, sorridiamo quando sentiamo quel caratteristico fetore di umido mentre ci apprestiamo, per l’ennesima volta, a suonare una cover di Lavoro.