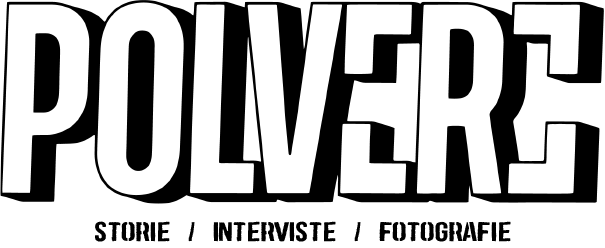I C’Mon Tigre ci conducono in un mondo primordiale dove regna la natura al suo stato più selvaggio. Un percorso sonoro complesso e immersivo, frutto di una ricerca compositiva che va oltre i generi e le loro consuetudini
Immagina un mondo agli albori della civiltà, dominato dalla fauna e dalla vegetazione. Oppure, uno scenario post-apocalittico in cui i palazzi, ricoperti di piante rampicanti, sono verdi torri abbandonate, imperitura testimonianza di un’umanità da tempo decaduta.
Immagina, ora, di chiudere gli occhi e di sentire i suoni dell’ambiente circostante: voci di prede e predatori, fruscii di vento tra le foglie, ritmi primitivi di nuove tribù nascenti alle appendici della foresta.
Immagina, infine, di visitare questo mondo sconfinato, con i suoi suoni e i suoi disordini – perfettamente naturali, secondo il principio dell’entropia –, entro i confini di una sala a quattro mura, tra le 22 e la mezzanotte di un giovedì qualunque.
 22 febbraio 2024. Siamo a Torino, Hiroshima Mon Amour: storico punto di riferimento per la musica live della città. In programma ci sono i C’Mon Tigre, un concerto molto atteso – almeno per quanto mi riguarda – di un collettivo tanto originale quanto unico nel panorama musicale italiano. La band mancava nel capoluogo piemontese dal 27 maggio dello scorso anno quando, ospite del Jazz is Dead, si era esibita al Bunker. Tuttavia, in quell’occasione il tempo a loro disposizione era limitato da una line up piuttosto densa e l’acustica della location non era certo delle migliori. Ma, soprattutto, il loro Habitat – ultima e sorprendente fatica discografica – era ancora in cantiere.
22 febbraio 2024. Siamo a Torino, Hiroshima Mon Amour: storico punto di riferimento per la musica live della città. In programma ci sono i C’Mon Tigre, un concerto molto atteso – almeno per quanto mi riguarda – di un collettivo tanto originale quanto unico nel panorama musicale italiano. La band mancava nel capoluogo piemontese dal 27 maggio dello scorso anno quando, ospite del Jazz is Dead, si era esibita al Bunker. Tuttavia, in quell’occasione il tempo a loro disposizione era limitato da una line up piuttosto densa e l’acustica della location non era certo delle migliori. Ma, soprattutto, il loro Habitat – ultima e sorprendente fatica discografica – era ancora in cantiere.
Il collettivo entra in scena e non pronuncia parola, né lo farà più avanti. Il set up del palco, del resto, già li presenta molto bene: ai lati la sessione ritmica, con batteria e xilofono, come colonne d’ercole del mondo che verrà; poco più verso l’interno, continuando la simmetria, i fiati promettono di coprire un range sonoro che va dal sax baritono al flauto traverso, passando per la tromba e il flicorno; al centro della scena, infine, un grosso timpano, un rullante, due chitarre elettriche – a sei e dodici corde – e un caro vecchio Moog, che giura di far tremare le fondamenta.
Il concerto si apre su una lunga distesa verde, l’impeto dei fiati – che, assoli a parte, quasi sempre si doppiano a vicenda – risuona lungo e dilatato, edificando un’architettura sonora che sembra introdurci a un linguaggio epico. La sessione ritmica proietta subito lo spettatore su uno scenario naturale, selvaggio e primordiale. La batteria percorre queste terre desolate come una locomotiva, tracciando un percorso connettivo tra le fermate Jazz e Funk. Ogni tanto si arresta di colpo, il tempo di qualche battuta ritmica per farci perdere l’orientamento tra le voci della foresta, poi riprende il suo tragitto: uno schema compositivo, questo, che sembra figlio delle influenze della musica elettronica.
I suoni della fauna locale si moltiplicano e sembrano avvolgerci da ogni dove, riprodotti con le tecniche più disparate: fragore di mani battute in contro tempo, vasi di latta che fischiano come uccelli, fruscii di tappi in plastica legati da una fune.

Come battezzato dallo spirito dell’Africa, l’elemento percussivo sembra caratterizzare l’intenzione con la quale viene suonato ogni singolo elemento: la chitarra elettrica – unico strumento a corde per quasi tutto il viaggio – fraseggia senza sosta ticchettando sopra i tasti; rullante e timpano a centro palco duettano – di tanto in tanto – con i fusti del drum set e lo xilofono, tra ambientazioni selvatiche e solismi “crimsoniani”, carica di tensione l’atmosfera. I bassi del Moog, come promesso, vibrano dal centro della terra.
Durante il live, il ruolo delle parti si mantiene quasi costante su questo schema. Gli scenari al suo interno, però, sono vari e sconfinati. La voce principale – accanto ai cori, che sembrano provenire dagli angoli remoti della selva – è l’unico elemento umano vagamente riconoscibile. Parla diverse lingue e sembra trasportarci in altrettanti luoghi differenti: dall’Africa all’Arabia, dall’America centrale ai Balcani. Un canto che risuona lontano e confuso, come da un megafono che, disturbato, pare sottolineare la distanza – se non l’incompatibilità – dell’elemento antropico rispetto a questo mondo.
Sedotti dalle tonalità minori, che hanno il sapore di un sorriso inquieto, viene voglia di ballare sulla terra nuda, come partecipi di un rito arcaico. Finché, inesorabilmente, il rito finisce e l’illusione volge al termine. Per due volte i C’Mon Tigre tornano sul palco, come a volerci diluire il trauma di un ritorno alla volgare civiltà. La folla, le luci, la strada di Via Carlo Bossoli: il sogno è finito. Eppure, il cuore ancora batte al ritmo del tamburo, ancora la foresta riecheggia tra i pensieri.