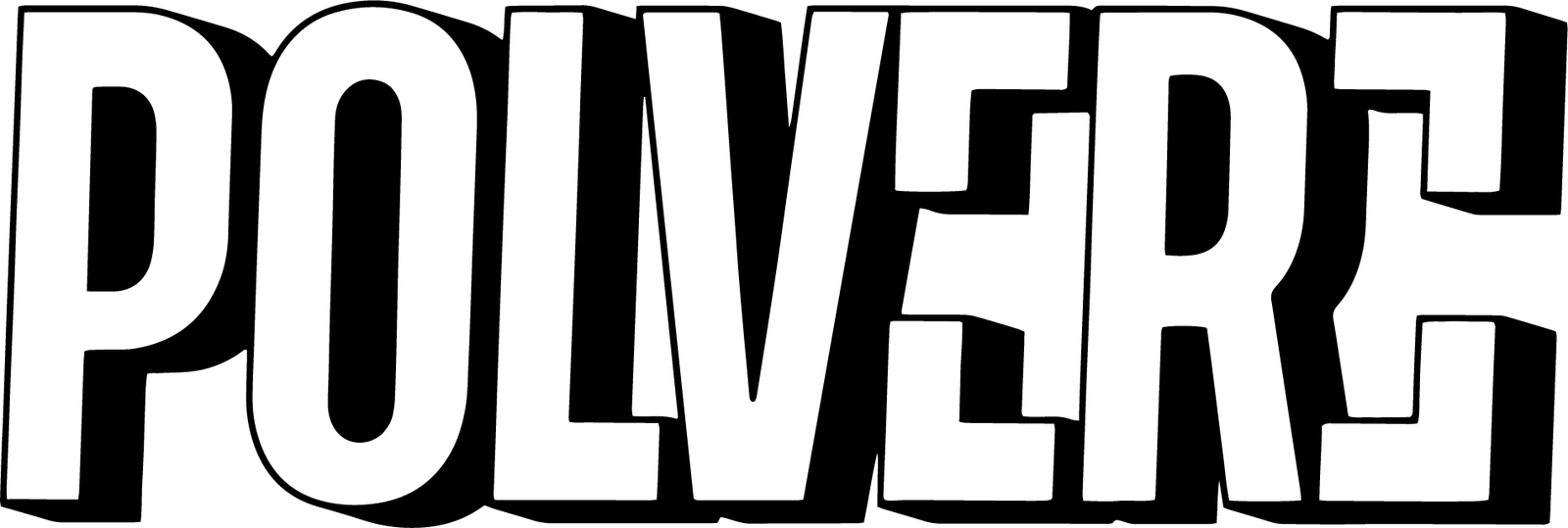Quando ascoltai per la prima volta A Well Made Woman, prima traccia di I’m Not Sorry, I Was Just Being Me, venni subito catturato dalla semplicità e dal rigore di quelle prime battute: voce ruvida e sensuale, ritmi magnetici, timbri cupi, distorsioni sporche e arrangiamenti minimal. Mi sentii trasportato istantaneamente nella loro intimità, nel loro «tiny flat, that has too much stuff in it», come diceva Craig Whittle in un’intervista a Rolling Stone.
In Big Swimmer, la coppia da Liverpool esce dal “tiny flat” e racconta la loro più recente esperienza negli Stati Uniti, tra scene cinematografiche, stati d’animo incerti e domande esistenziali: «When the river is floating and / And the mouth has come to its end / Do you carry on swimming or / Do you jump out and grab your towel?».
Finalmente la band riesce a catturare la dinamica e l’energia delle loro esibizioni dal vivo e imprimerla in studio, anche grazie ad Ali Chant – produttore di PJ Harvey e Perfume Genius – che sembra aver migliorato il loro sound senza comprometterne l’integrità.
L’ album si muove, respira, passa con fluidità tra rock alternativo, indie rock, post rock, folk e shoegaze. Le tracce si alternano armoniosamente, creando un fluente intreccio di pieni e vuoti, dove i pieni sono rappresentati da brani come Lily Pad, Davey Says, New York, Let’s Do Nothing, e i vuoti da Suddenly, Your Hand o This Wasn’t Intentional, creando un equilibrio dinamico che dimostra la loro maestria nel gestire la metrica e mantenerci incollati alla loro musica.
Big Swimmer si apre con il brano omonimo, dove Hannah Merrick dimostra che Joni Mitchell continua a essere un’ispirazione per molte giovani cantautrici. La frontwoman ci accoglie con una voce vellutata, quasi sussurrata, accompagnata da una chitarra acustica calda e leggera, evocando l’atmosfera di un camino acceso. Questo intro ci sorprende, facendoci dimenticare per un attimo la crudezza e la spigolosità del primo album. I King Hannah ci danno il tempo di accomodarci, per poi accendere la distorsione e offrirci un finale di canzone che riporta al loro mondo, ai loro suoni. Da Joni Mitchell si passa a The Velvet Underground & Nico; con eleganza, le linee vocali si spogliano di orpelli folk e si abbandonano alla semplicità di un ritornello ampio, asciugandosi in un outro che ricorda Heroin.
Dalla seconda traccia, sentiamo uno dei tanti spoken del disco: «Probabilmente è il frutto di diversi ascolti che ho fatto durante il periodo di scrittura del disco. Sentivo molto Cassandra Jenkins, Sheryl Crow, Bill Callahan», racconta Hannah a Billboard; mentre Craig in The Mattress e Suddenly, Your Hand si abbandona ad assoli aggrovigliati, spezzando gli schemi minimalisti slowcore con toni irsuti e spinosi, che accarezzano la psichedelia.
Un tempo di marcia spezza il viaggio lisergico e Milk Boy (I Love You) entra a gamba tesa con un racconto di vita vissuta. Un potente riff di chitarra penetra la narrazione come un pugno, enfatizzando la violenza del finale della storia. Ancora qualche secondo per digerire le emozioni ed ecco che di nuovo l’album si apre, facendoci immergere nella psiche del duo. Il dolore e la malinconia, costanti nelle loro vite e nella loro musica, ci avvolgono, trasportandoci in un vortice emotivo.
Tra suoni secchi e un’andatura ipnotica ci troviamo avvolti da un muro di distorsione, simile al travaglio interiore di Hannah, in una sequenza di eventi che la travolge come protagonista o spettatrice impotente: così in Somewhere Near El Paso ci sentiamo catapultati in mezzo al deserto, in un viaggio on the road, da sentire la gola secca.
Siamo al “gran” finale: This Wasn’t Intentional è così spoglia che possiamo sentire il nostro stesso respiro tra una battuta e l’altra, mentre in John Prine On The Radio emerge un desiderio di semplicità e benessere. Le sonorità folk, che richiamano il brano d’apertura, creano un senso di coesione. In questa ballad, le voci dei due si uniscono in armonie che ci cullano dolcemente verso la chiusura.
Il disco sembra emerso con naturalezza e spontaneità, senza troppe pretese; ci parla in prima persona e non ha paura di farlo nella maniera più vicina al gusto musicale del duo. Dall’inizio alla fine, assistiamo a un’evoluzione matura e consapevole della band che, pur esplorando varie influenze, rimane fermamente legata al sound che li ha consacrati nel loro album di debutto. Come un grande film on the road, Big Swimmer è il sequel che ci meritiamo da un progetto che sembra non avere grandi problemi di identità, ma soltanto tanta voglia di crescere.