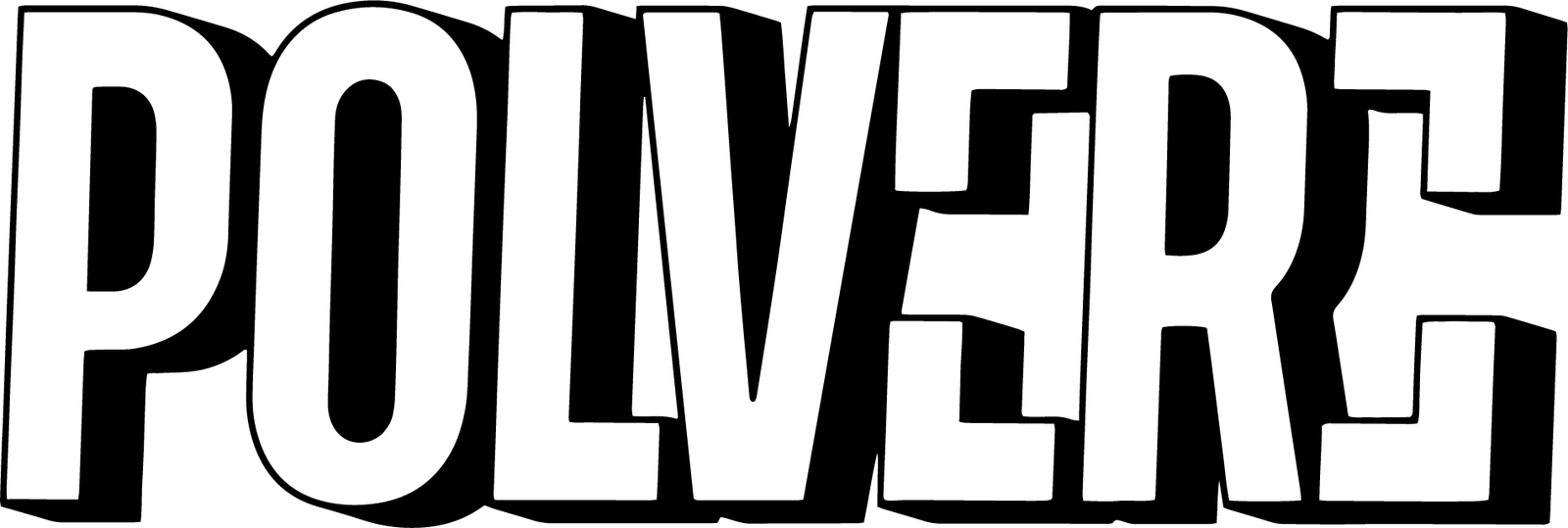Stop Making Sense, il film-concerto dei Talking Heads diretto dal registra Jonathan Demme è da poco passato nei cinema italiani in versione restaurata in 4K, con la colonna sonora rimasterizzata da Jerry Harrison, chitarrista e tastierista della band. Tra chi è riusciuto ad assistere alla proiezione del film in una delle tre serate di programmazione — dall’11 al 13 novembre — ci sono due tipi di persone: chi è uscito dalla sala cercando di ondeggiare sinuosamente sulle ginocchia come David Byrne in Life During Wartime e chi mente.
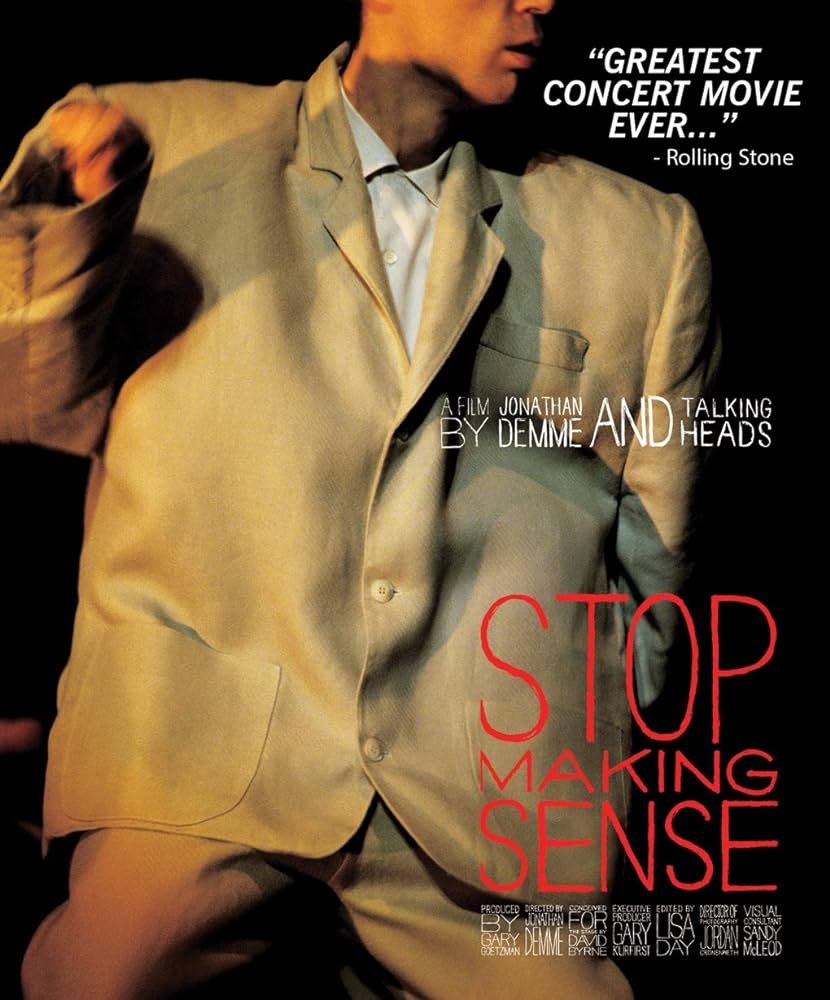
Il film fu girato in quattro serate al Pantages Theater di Los Angeles tra il 13 e il 16 dicembre 1983, quando la band stava portando in tour l’album Speaking in Tongues. Il progetto cinematografico di Jonathan Demme, che è impossibile scindere dall’estro e dalle scelte stilistiche del frontman David Byrne, era a dir poco ambizioso: a movie for the audience, un film che trasmettesse allo spettatore la sensazione di aver davvero preso parte a quello show, senza mai distogliere le telecamere dal palco,fatta eccezione per l’ultimo brano, Crosseyed and Painless, quando per la prima volta le riprese si spostano sul pubblico che per tutto il concerto abbiamo solo potuto sentire e mai vedere. Le telecamere furono posizionate in vari punti del teatro: luoghi strategici per registrare ogni istante del concerto ma, al contempo, permettere ai Talking Heads di muoversi liberamente come solo loro sanno fare. I piani sequenza che ne derivarono furono tagliati e mixati assieme da Jonathan Demme e David Byrne in persona, che non lasciò nulla al caso in post-produzione, nemmeno gli errori: «anche gli errori sono importanti, non vanno trascurati». Lo show non doveva apparire perfetto, doveva essere reale.
I componenti della band e tutti i musicisti fanno il loro ingresso in scena uno alla volta, brano dopo brano. Anche la scenografia del palcoscenico è in continuo divenire, lo stage viene progressivamente preparato in corso di concerto e gli strumenti fanno il loro ingresso solo quando necessari, così come chi li suona. David Byrne comincia lo show da solo, con la chitarra acustica e un mangianastri che riproduce la base ritmica di Psycho Killer ma, nonostante il palco sia ancora vuoto, appare incredibilmente pieno, colmo dalle sue movenze schizzate, dalla sua gestione degli spazi e dalla sua incredibile presenza scenica. Sulle note di Heaven, Byrne viene raggiunto dalla bassista Tina Weymouth ed è inevitabile trovarsi a immaginare a come il suono pulito e rotondo frutto frutto dell’intesa dei loro strumenti possa aver scaldato il teatro intero, dalle prime alle ultime file. La formazione della band si completa solo al quarto brano, Found a Job, ma è sulle note di Slippery People che finalmente esplonde il sound avant-funk che ha reso celebre la band.
Qualcuno potrebbe dire che la cura quasi maniacale dei brani, delle coreografie, dei singoli dettagli – basti pensare che David Byrne scelse personalmente la tonalità del colore delle luci e fece dipingere di nero ogni supporto metallico, anche quelli degli strumenti, affinché non distogliessero l’attenzione dall’esibizione – abbia reso questo concerto meno naturale, artificioso. In realtà, il montaggio finale risulta perfettamente fedele a quella che fu la resa scenica del concerto: nessuna forzatura, nessuna teatralità fine a se stessa o motivata solo dal fine ultimo della realizzazione di un film che, ora possiamo dirlo, era destinato a segnare la storia della musica.
I Talking Heads portarono a compimento ciò che sapevano fare meglio: esprimere il loro genio attraverso la musica. Ne è derivato un film che è molto più di un film-concerto: per un’ora e mezza di riprese, le arti del cinema, del teatro, della musica e della danza si incontrano per dare vita a una performance impeccabile. La spettacolarità, la ricerca del grottesco e dell’esagerazione – si pensi al famoso big suit indossato da Byrne per gli ultimi tre brani, abito fortemente voluto dal frontman dopo aver scoperto i vestiti tradizionali del teatro Nō in Giappone – sono perfettamente congrue con l’esibizione e non la rendono meno efficace; semmai, l’arricchiscono.
A quarant’anni dalla sua realizzazione, ciò che rende Stop Making Sense ancora così tremendamente attuale è proprio la sua autenticità, frutto della spontaneità di una band che non si è mai soffermata a compiacersi dei propri risultati ma, al contrario, si è sempre orientata alla ricerca costante di nuovi stimoli, strizzando l’occhio a ogni forma d’arte e a ogni sua declinazione, con una sensibilità libera dai pregiudizi e un genuino desiderio di creare sempre qualcosa di originale.
Ciò che rende una band eterna è la voglia costante di sperimentare e la sete di scoperta. Con Stop Making Sense, i Talking Heads vollero mettersi alla prova e superare loro stessi: 40 anni dopo, senza averne mai dubitato, confermiamo che ci riuscirono.