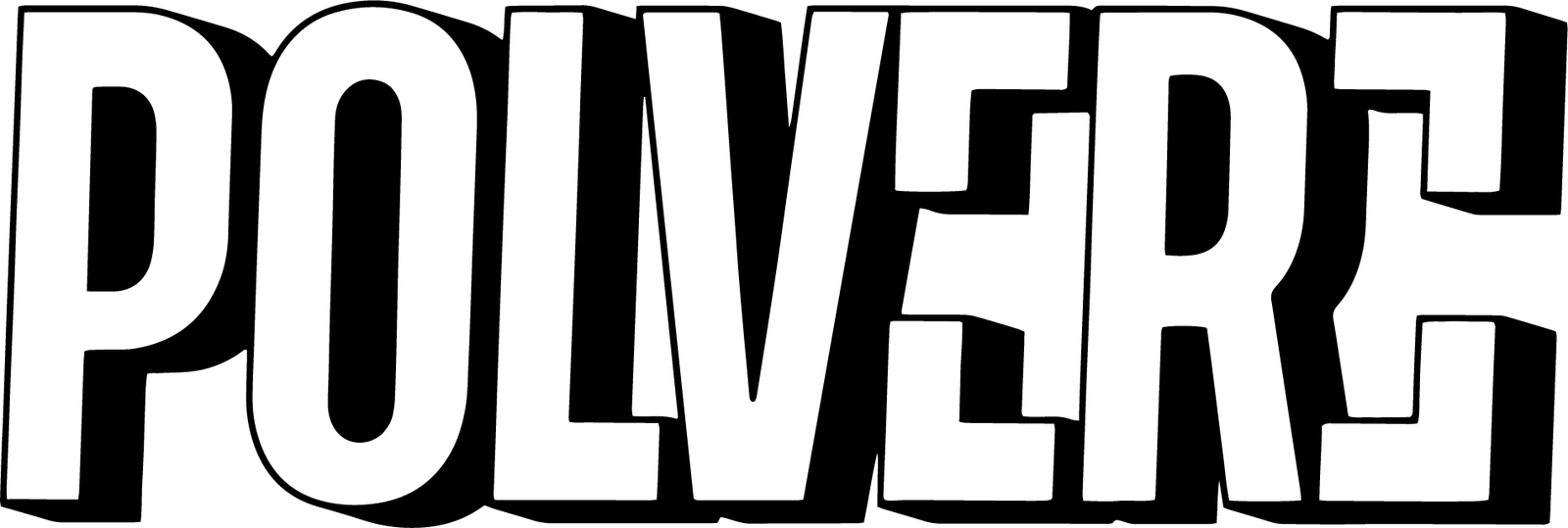Passo qualche giorno in Emilia, una sera faccio amicizia con un ragazzo e lui, verso le due di notte, mi chiede: «Ma tu ti ascolti ancora il punk? Che senso ha? Per me è una roba morta all’inizio degli anni Novanta. Cos’ha ancora da dire?». Io, sul momento, gli rispondo che essere sovversivi non ha una data di scadenza, che gli ideali che porta e gli spazi che abita sono ancora pregnanti, rivoluzionari. O, almeno, questo è ciò che gli avrei detto se non fossi stata al sesto drink. In realtà, probabilmente mugugno: «Oh, a me piace, W l’anarchia sempre, diofa». Non altre parole vengono proferite a riguardo. Thanks for coming to my TED Talk!
Devo ammettere, però, che passare ogni sabato sera ad arraffarsi gli sputacchi di maschi bianchi etero cis che urlano «oi!oi!» o screamano «fanculoleguardie!» come ghepardi dalla coda atrofizzata sotto una grossa pietra, talvolta mi fa domandare: Cos’ha ancora da dire il punk hardcore? Penso a tutte le derivazioni e commistioni di genere che ne sono esalate, le quali contengono in ogni caso ancora quell’onta sovversiva nei testi, nell’attitude e nella scelta di suonare principalmente alle Taz e negli spazi underground; post acid tekno harsh hypernoise skramz, quelle cose lì. I dell’anima nella serpe e i Serpe Terror in Italia; i Duma in Kenya; il progetto argentino mis sueños son de tu adiós… forse allora aveva ragione il ragazzo incontrato in Emilia: piantiamola di fare ogni settimana il punk hardcore o il power violence e il crust negli squat – piantiamola anche di suonarlo – e apriamoci maggiormente a nuove sperimentazioni sonore.
Poi, però, ho scoperto le Taqbir e la mia tsunamica invettiva si è placata come se una novella manifestazione di Orfeo in giacchetto di pelle, anziché ammorbarmi con la lira, mi avesse infilato un paio di xanax nella birra, approfittando della mia distrazione da predicatrice dell’apocalisse sull’incipiente decesso del punk.
Le Taqbir vengono dal Marocco e, anche se solo la cantante è una donna, le classifico come riot grrrl e mi riferirò a loro col femminile sovraesteso, poiché la loro è una musica che inneggia alla liberazione femminista. Il loro EP del 2021 Victory Belongs To Those Who Fight For A Right Cause è un po’ un mix tra il noise aromatizzato al turbo-fuzz delle giapponesi Melt-Banana e i riffoni hardcore che istigano al circle pit dei Minor Threat. Al suo interno, quattro tracce:
- Sma3 (Listen)
- Aisha Qandisha
- Tfou 3lik (I spit on you o Fuck you)
- Alzuki Akbar (My ass is the greatest)
Sulla copertina, una palla da demolizione sta distruggendo la Kabah, il monumento di pietra posto nel centro della Mecca, verso il quale i fedeli si prostrano durante la preghiera. Le Taqbir – che è l’urlo di battaglia Allāh akbar (Allāh è il più grande), pronunciato con le mani levate in alto – raccontano in un’intervista su Maximum Rock’n’Roll che «la Mecca è il simbolo del capitalismo poiché l’Arabia Saudita guadagna milioni di dollari con il turismo spirituale dei pellegrini, soldi che vengono poi investiti per bombardare lo Yemen, per esempio».
Nonostante all’interno dei loro testi – scritti in darija (l’arabo colloquiale marocchino) – denuncino l’oppressione della donna da parte di una comunità islamica ancora troppo spesso oscurantista e parlino di libertà dei corpi, devono suonare velate perché farsi riconoscere dalle autorità equivarrebbe all’incarcerazione certa. Infatti, in Marocco non ci vivono più. Troppo repressivo, troppo pericoloso. Dalle loro famiglie sono state ripudiate ma, fortunatamente, hanno trovato tra Europa e Stati Uniti una comunità punk di amicǝ e alleatǝ.
Tra Casablanca, Rabat e Tangeri una micro scena punk esiste, ma questa è vissuta nella più totale segretezza: in questo caso si può davvero parlare di underground; a portare avanti i valori femministi, queer, atei e anarchici in Marocco si può rischiare anche la morte.
I loro testi sono schietti e ossuti. Sma3 è un’invettiva contro chi ancora considera un’eresia un corpo tatuato; Aisha Qandisha nel folclore marocchino è la jinn (spirito) di una donna che seduce gli uomini e poi li sgozza; in Tfou 3lik mandano semplicemente a fanculo chi le vuole vedere sprofondare nella rovina; mentre in Alzuki Akbar cantano, parafrasando: «il mio culo è meraviglioso e non me ne vergogno. Non metterò un velo e non mi metterò a pregare, ti diranno che non hai rispetto per te stessa anche se indosserai l’hijab, il niqab o il burqa. Il mio culo è grosso e indosserò jeans attillati, così che tuttǝ possano ammirarlo».
Questo, per me, è l’unico modo ancora davvero sovversivo di fare punk. Se si rischia tutto è perché la perdita è già avvenuta: il cuore dovrebbe essere vuoto, invece aumenta la frequenza del battito per connettersi alle proprie sorelle di sventura, che esistono a loro volta nella perdita, e combattere insieme; in questo caso, contro l’oppressione patriarcale.
Di musicistǝ islamicǝ che portano avanti i valori anarchici ce ne sono parecchǝ. Un’altra corrente interessante è quella del taqwacore e dell’harami punk, generi coniati da immigratǝ mussulmanǝ statunitensi che narrano delle discriminazioni che subiscono ogni giorno e indagano il rapporto tra fede islamica e punk, senza rinunciare alle loro radici culturali ma rielaborandole in un’ottica femminista e antistatalista. Ci sono, per esempio, gli storici Haram di New York, le Voice of Baceprot dall’Indonesia, Zoufrya dalla Francia, gli Zanjeer da Berlino, gli Ikhras da Londra.
In Italia, per quanto non credo si identifichino nel genere taqwacore, abbiamo gli HARAM! – stoner da Trieste –, la Dj Kandeesha di Trento e la Dj Turbolenta Leila, che fanno decolonial techno.
Se conoscete altrǝ musicistǝ, non esitate a farmelo sapere perché, non so voi, ma io – da musicista, in primis – ho sempre meno voglia di portare i miei ritriti complessi biancocentrici sul palco. In compenso, c’è una minuscola boxeur che mi tartassa il cuore di pugni dalla voglia di arraffarmi gli sputacchi di tuttǝ questǝ artistǝ sotto palco.