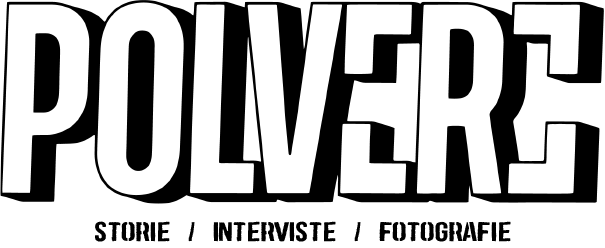I KOKOKO! sono guerriglieri del suono e vanno alla radice di quella che dovrebbe essere una forma espressiva: la necessità di comunicare con una spontaneità che appartiene solo a chi è libero da preconcetti
Il collettivo originale, composto dai congolesi Oweke, Bomolo, Lokombe e Bianko, riunito nel 2016 dal bretone Xavier Thomas, produttore ed esploratore di musica elettronica conosciuto come Débruit, animava le frenetiche notti di Kinshasa trasformando letteralmente i rifiuti in musica con strumenti autoprodotti, costruiti utilizzando bottiglie di detergente per creare ibridi tra xilofoni e congas, lattine, microfoni e diffusori di vecchi telefoni usati come pickup per strumentazioni più complesse come chitarre e bassi, stoviglie, parti di veicoli e altri materiali da discarica.
Imbattersi nella musica dei KOKOKO! significa immergersi in una storia unica.
Débruit fu invitato a Kinshasa dal regista francese Renaude Barret, durante la realizzazione di System K, un documentario sulla condizione precaria degli artisti nella capitale della Repubblica Democratica del Congo, senza aspettarsi di diventare attivamente parte della scena locale: «Sono andato nel complesso dove costruiscono gli strumenti e, prima di collegare qualcosa, ho passato due o tre settimane ad ascoltare. Avevano questo suono punk funk, sono rimasto davvero sbalordito», ha dichiarato Débruit in un’intervista del 2019.
L’unione tra la scena spontanea congolese e il contributo elettronico di scuola europea di Débruit si traduce in una colonna sonora perfetta per una narrazione ecopunk ambientata in un mondo che sta causando danni irreparabili all’ambiente, in realtà distanti dai nostri occhi: il suono dei KOKOKO! ci entra nello stomaco, palesa la contemporaneità dell’estrema periferia dell’occidente come in un racconto ambientato in un futuro distopico di Philip K. Dick, un suono definito dal frontman Makara Bianko “tekno kintueni”, traducibile a spanne come “techno niente”: musica elettronica che ha fatto il giro e ha ricominciato a suonare senza una fornitura costante di elettricità, senza risorse, che trae ispirazione dai rumori del fervore di una città inquieta come Kinshasa, con un mix di linguaggi comprendenti francese, lingala, swahili e kikongo.
«Le nostre materie prime ci vengono rubate, tutte le nostre ricchezze vengono portate via. Sono abituati a costruire tecnologie altrove… Quando il mondo butta via i prodotti, tornano qui logori», dice la band nella voce fuori campo del documentario System K. «Utilizziamo la spazzatura per creare strumenti. Non servono parole, i nostri strumenti sono il messaggio».
Sì, è questa la voce esotica nel 2024, non quella romanzata dagli elmetti coloniali, le camicie color khaki e dalle lussuose percussioni di Africa dei Toto.
A un ascoltatore occidentale assuefatto da post-produzioni iperboliche, i singoli brani di Butu possono sembrare legati assieme come i loro strumenti, con spago, nastro e chiodi. La forza del loro groove, nel nuovo disco, sta proprio nella cruda scelta stilistica di rimanere il più possibile genuini: li abbiamo visti sorprendere il pubblico a un Tiny Desk Concert con un’energia spontanea traboccante. Il fil rouge di Butu è lampante fin dalla traccia di apertura, Butu Ezo Ya, che raccoglie, campiona e rielabora i suoni del traffico e delle attività della concitata capitale congolese.
Il ritorno di Makara Bianko e Débruit a cinque anni da Fongola, seppure privati di due elementi della formazione originale – fondatori dei Ngwaka Son Systéme –, è forse meno sorprendente ed eclettico del disco di debutto, ma sicuramente più incalzante e a fuoco.
L’Oxford English Dictionary definisce banger come un modo informale per indicare «a song with a loud energetic beat that is good for dancing to» e Butu, che significa “notte” in idioma Lingala, di banger ne è pieno, con linee di basso iterative, tappeti di synth e sezioni ritmiche ossessive, spezzate da metriche testuali organiche e dagli oggetti percossi.
Oltre alle anticipazioni dei singoli Bazo Banga e soprattutto la ballabilissima Mokili, accompagnate da video valorizzati per mezzo di un’estetica schietta e ben coordinata, un buon DJ potrebbe tranquillamente inserire nella selecta brani come Donne Moi, già spoilerato dalla colonna sonora del videogioco FIFA, da qualche decennio una curiosa finestra popolare sulla World Music, o chicche come Elingi Biso Te.
Ecco, quando mi sento raccontare che Lou Reed registrò un disco utilizzando un basso entry-level Squier come esempio di adattamento e di virtù, penso a questi ragazzi con una chitarra a corda singola costruita con l’asse di un bancale, i pezzi di un vecchio Motorola e due lattine.
È un disco fondamentale? No. È un disco contemporaneo che racconta una storia partendo da un’esigenza di espressione primordiale, da ascoltare dall’inizio alla fine. L’occasione di vivere da turisti in cuffia la calda notte di Kinshasa.
E magari, per chi ne ha la possibilità, vederla dal vivo all’Ortigia Sound 2024, in Sicilia a inizio agosto.