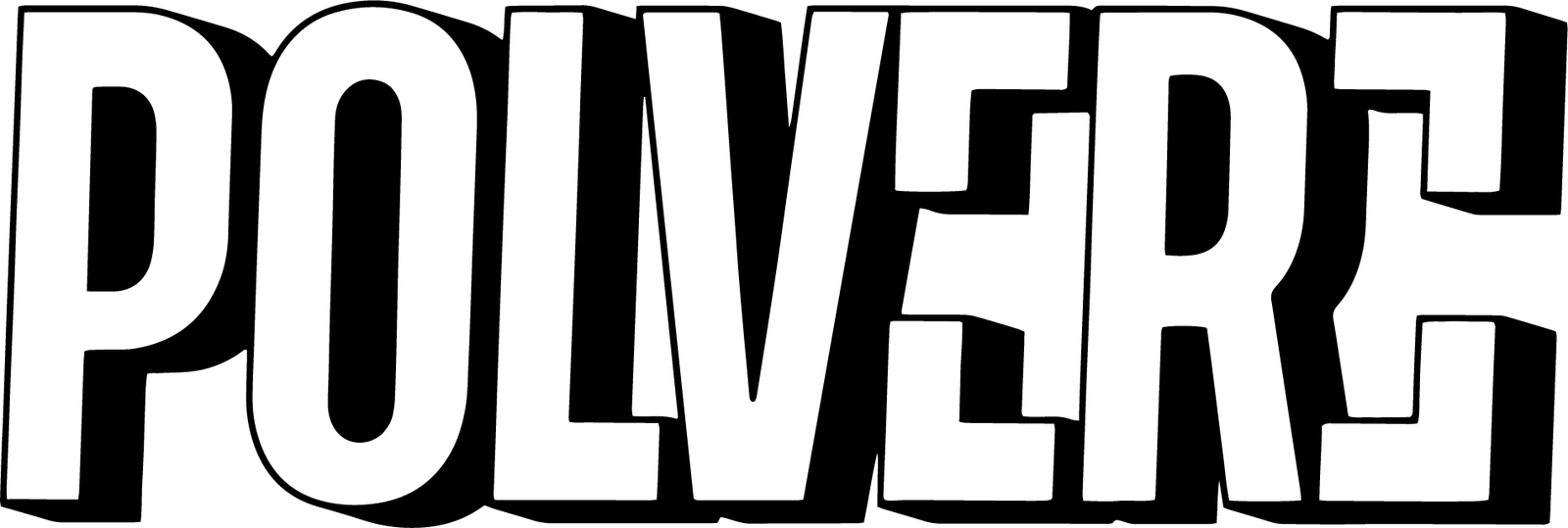Nessun genere musicale, probabilmente, vive di canoni estetici e musicali così ben definiti come il synth pop. Basti pensare, ad esempio, a gruppi storici come Orchestral Manoeuvres in the Dark o Human League, per rendere l’idea. Tra le band che, più di ogni altra, negli ultimi tempi hanno cercato di farsi carico dell’eredità di quei suoni degli anni ottanta per portarli nel presente e nel futuro ci sono sicuramente i Nation of Language.
A stretto giro di posta dal precedente lavoro Strange Disciple, il trio di Brooklyn è tornato immediatamente sulle scene con il nuovo album Dance Called Memory (il quarto in cinque anni, segno di una vena creativa decisamente prolifica), segnando un passaggio di etichetta – dalla belga PIAS alla Sub Pop di Seattle – pur mantenendo lo stesso e importante produttore, Nick Milhiser degli Holy Ghost!, già all’opera dietro le quinte con gli LCD Soundsystem. Confermata anche la formazione, che insieme all’anima della band composta dal frontman, voce e chitarra Ian Richard Devaney e dalla tastierista Aidan Noell, vede al basso la presenza di Alex MacKay.
Con Dance Called Memory, i Nation of Language seguono ladirezione intrapresa con Strange Disciple, allontanandosi sempre più dal synth pop diretto e pulsante degli esordi – Introduction, Presence e A Way Forward – per abbracciare sonorità più eteree, sospese e riflessive. La voce di Devaney assume toni quasi distaccati, mentre l’uso inedito di fiati, archi, chitarre acustiche e del (quasi) falsetto intrecciati ai sintetizzatori apre il loro universo sonoro a derive folk rock e d’atmosfera, senza però recidere le evidenti radici elettroniche. I temi affrontati — inquietudine, morte, disillusione, tempo e memoria — trovano dunque spazio in un racconto musicale che alterna introspezione e tensione emotiva, concedendo comunque qualche momento più ritmico e ballabile, seppur meno immediato rispetto al passato.
Il disco si apre con Can’t Face Another One, brano sospeso e fragile che racconta il peso dei giorni in un crescendo che si libera in un canto di liberazione («The memories run / I can’t pause a single one / And they prey upon my heart»), per poi accendersi improvvisamente con In Another Life, in grado di scatenare la pista da ballo esorcizzando i difetti dell’amore («Love, love / What a waste of time (…) But you know / It gets real low / When you go»). A seguire, Silhouette canta le ombre che si nascondono dietro ai cambiamenti e alle perdite («Wait, don’t desert us all / Can’t look to myself anymore»), mentre la successiva Now That You’re Gone riflette sul lutto impregnata di inquietudini musicali ed esistenziali («Through the walls / Whispering goodbye / You’ve run»).

L’apice arriva nella parte centrale dell’album, con i due singoli I’m Not Ready For The Change e Inept Apollo – intervallati dall’acustica Can You Reach Me? –, simbolo del senso di inadeguatezza che la band vuole far trasparire non troppo sottotraccia fin dall’inizio: la prima aleggia sul tema portando le sonorità verso atmosfere tipicamente shoegaze che dimostrano la volontà di uscire dai confini («Look, all I know / Is I’m on the floor again / Pressed beneath my skin»), mentre la seconda entra a gamba tesa con un basso serrato e synth brillanti («A dream that fell / Lamented in the morning glow / Embraced and left alone»).
La chiusura segue l’andamento ondivago dell‘album: prima di tutto con la lenta, malinconica e inesorabile immersione di Under the Water («Bound in inhibition / Diving further down»), poi con il tormento interiore di In Your Head ballato su ritmi forsennati e robotici con tanto di synth ipnotici e ritornello trascinante («Rain coming on / And I’m hanging on the line / A simple sideshow»), e infine con Nights of Weight, ballata notturna che lascia sospesi tra dolore e speranza («Fixing our eyes on the door / It’s never closed»).
Nel complesso, la qualità compositiva resta molto alta e consolida i Nation of Language tra le realtà più interessanti della scena contemporanea, capace di cercare una propria via personale al synth pop senza la velleità di inseguire le mode o apparire accattivanti a tutti i costi. Il grande merito di questo album è quindi quello di trasformare un linguaggio sonoro spesso associato al revival in uno strumento autentico di confessione. Tuttavia, a lungo andare, l’ascolto può risultare un po’ ripetitivo e privo di quei brani capaci di lasciare davvero il segno, quelli che “spaccano” e restano nella memoria.
Dance Called Memory è un lavoro coerente e coraggioso, che segna la maturità del gruppo e ne conferma l’ambizione artistica, pur lasciando la sensazione che il meglio debba ancora arrivare. A proposito, pur comprendendo la scelta di essere così prolifici, siamo proprio curiosi di capire cosa succederebbe se, invece di far uscire un disco all’anno, la band ci facesse aspettare un po’ di più per qualcosa di davvero rivoluzionario.