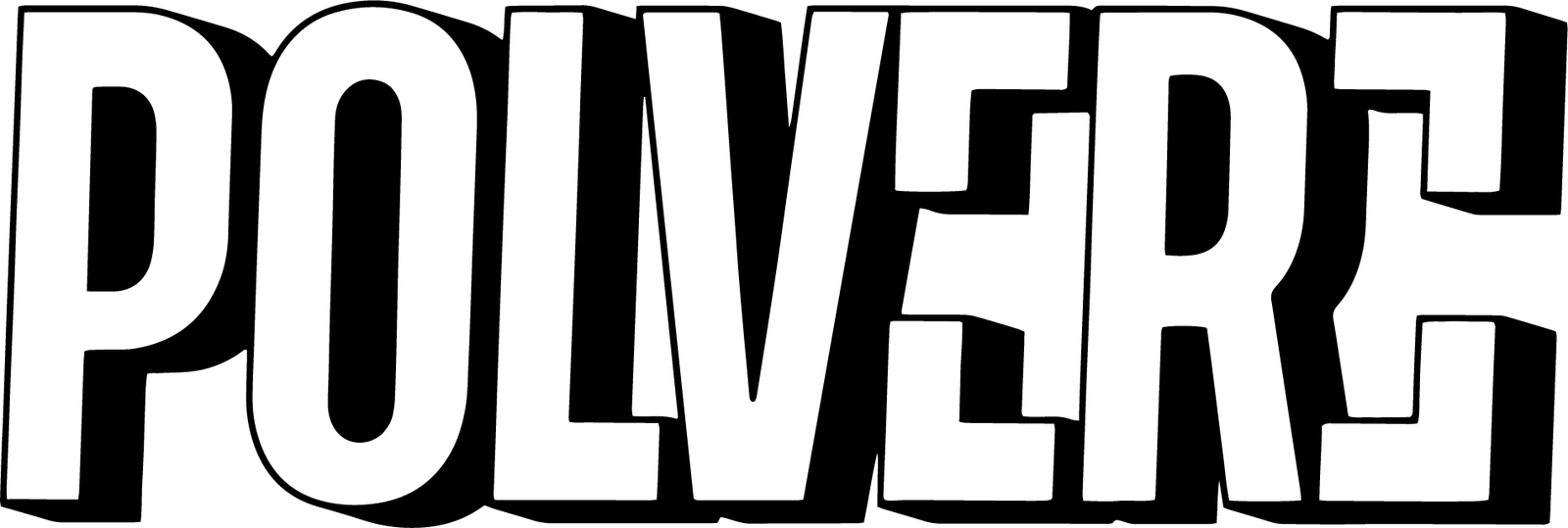Parlare di qualcosa come influente – in un’epoca in cui le tendenze evaporano nel giro di poche ore, confinate in bolle sempre più circoscritte – è un esercizio ambiguo che dice molto di come percepiamo oggi la rilevanza culturale. I meccanismi di consolidamento sono stati scardinati da un’esperienza individuale frammentata, filtrata da social media che restringono il campo visivo fino a deformarlo. Ciò che per un orizzonte personale appare centrale, altrove non lascia traccia. Eppure, alcune traiettorie riescono a infrangere questi confini, imponendo un’eco che torna ciclicamente e che si riconosce con immediatezza. Quella dei Deftones è una di queste: un’influenza che affonda le radici anche nel ritorno ossessivo verso il paleolitico di internet, il tempo sospeso tra la fine degli anni ’90 e l’inizio dei ’00.
La band californiana ha inciso quelle coordinate con precisione, ridefinendole e spingendole oltre i limiti del nu metal inteso come fenomeno di massa, per portarle in territori più stratificati, porosi, aperti a influenze eterogenee. Oggi, se fenomeni apparentemente eccentrici come il cosiddetto baddiecore riescono a mescolare la minacciosità del metal con il linguaggio pop in un continuum fluido, è anche perché i Deftones hanno costruito nel tempo un lessico estetico preciso, capace di sedimentarsi nella memoria collettiva e di rinnovarsi nelle dinamiche della rete. Un paesaggio sonoro in cui riff taglienti, ritmiche fratturate, derive shoegaze e nu metal, insieme alla voce ansimante di Chino Moreno, non funzionano soltanto come marchi di fabbrica, ma come significanti autonomi, vettori di un immaginario che negli anni ha trovato risonanza in contesti culturali sempre diversi. Nel linguaggio rizomatico della rete, quella dei Deftones è un’influenza che si è frantumata e moltiplicata, generando derive impreviste, autonome, spesso effimere ma persistenti nella loro capacità di riemergere in forme sempre nuove. È in questa propagazione incontrollata, al tempo stesso caotica e coerente, che si può leggere la profondità del loro lascito.
Posizionare e analizzare una nuova uscita discografica di un gruppo la cui influenza non solo attraversa ma definisce le caratteristiche del contemporaneo assume quasi un carattere metafisico. Come se l’intero percorso dei Deftones fosse una profezia che continua ad autoavverarsi: materializzandosi nelle traiettorie imprevedibili del loro lascito spesso lontanissime dalle intenzioni originarie ma ugualmente riconducibili a quella matrice iniziale. Parlare del loro ultimo lavoro in studio, private music, significa muoversi in un territorio in cui i linguaggi della rete sono parte integrante del discorso: spazi in cui l’intimità privata e la dimensione pubblica si confondono, dove il personalismo individuale e l’universalità dell’esperienza condivisa si intrecciano in una dinamica costante di influenza reciproca, capace di ridisegnare continuamente i contorni di ciò che la musica è e rappresenta nel presente.
In questa prospettiva, il titolo del disco definisce sin da subito un contesto di senso netto, inscrivendolo con precisione sia all’interno della discografia dei Deftones, sia nel momento culturale in cui emerge. Il concetto di privato, oggi, ha assunto sfumature contraddittorie che sfuggono al controllo del singolo e si estendono in una dimensione pubblica, collettiva, costantemente esposta. L’intimo si dissolve, si frammenta in una pluralità di sguardi e appropriazioni, fino a diventare un’esperienza condivisa, talvolta impersonale, in un flusso continuo di riuso e risignificazione.
È su questa tensione che private music sembra ergersi: non soltanto come titolo, ma come dichiarazione di poetica. Un’indicazione di rotta che intreccia la storia della band, la sua crescita e la stratificazione delle sue influenze, con la consapevolezza di essere diventata qualcosa che eccede la volontà autoriale, un organismo che appartiene anche a chi lo attraversa, lo interpreta e lo rimodella. Questo decimo album si offre come spazio di osservazione privilegiato di quella dinamica, come se i Deftones avessero deciso di non limitarsi a ribadire i propri codici sonori, ma di esplorare la condizione stessa di ciò che, nell’ecosistema della rete, diventa linguaggio collettivo. In questo senso, private music non è solo un’opera nuova, ma anche uno specchio in cui si riflette la traiettoria di un gruppo che, suo malgrado, è diventato nodo di connessioni culturali che continuano a moltiplicarsi e a riconfigurarsi nel tempo.
private music non è soltanto un nuovo capitolo discografico, ma un ambiente sonoro che si muove in tensione continua tra peso e leggerezza, tra urgenza fisica e dissoluzione eterea. L’ascolto si dispiega come un paesaggio instabile, in cui le architetture più solide si sgretolano per lasciare spazio a strati sovrapposti, traslucidi e inafferrabili. È un disco che non si limita a riaffermare un’identità, ma la mette in discussione per ridefinirla: una sorta di campo aperto, dove il linguaggio storico dei Deftones diventa materia plastica, fluida, pronta a contaminarsi. Rispetto alla stratificazione controllata di Gore e alla tensione a tratti muscolare di Ohms, qui la band sembra aver ritrovato un equilibrio più naturale, quasi organico, tra i suoi poli opposti. La psichedelia di fondo — che per anni è rimasta in filigrana, mai davvero protagonista — diventa ora un motore narrativo. Non è un vezzo estetico, ma una dinamica che attraversa ogni brano, generando una dimensione ipnotica e dilatata che convive con la fisicità dei riff più incisivi. Allo stesso modo, i richiami allo shoegaze — da sempre un codice sotterraneo nel lessico della band — emergono qui in forme più definite, finalmente armonizzate con l’ossatura heavy. Questa miscela non è un ritorno nostalgico agli anni di White Pony o Diamond Eyes, ma un avanzamento: un lavoro di sintesi che riporta i Deftones allo stesso livello creativo dei loro momenti più alti.
Il lavoro di produzione di Nick Raskulinecz amplifica questa sensazione di lucidità. Da un lato, c’è una definizione chirurgica che permette a ogni dettaglio di respirare; dall’altro, un’immersività quasi sensoriale, che avvolge l’ascolto in una saturazione atmosferica. È un suono che sembra collassare su se stesso per poi ricomporsi, che prende i codici storici della band — le chitarre ipnotiche, le ritmiche fratturate, la voce di Chino Moreno sospesa tra sussurro e ferocia — e li proietta in uno spazio nuovo, più stratificato e instabile. Non c’è linearità, ma un movimento rizomatico, un continuo slittamento tra forme. In My Mind Is a Mountain, primo frammento dell’album, questa dinamica si manifesta con forza: un riff pesante come pietra che progressivamente si sfalda in un ambiente rarefatto, quasi liquido. Più avanti, Souvenir condensa la tensione del disco in un vortice emotivo che parte da un’intimità soffocata per aprirsi in un’esplosione catartica, mentre Departing the Body chiude il percorso dissolvendo ogni elemento in un silenzio sospeso, come se la materia stessa del suono si sfaldasse.
Più che una sequenza di brani, quello che emerge è un sistema di corrispondenze, un lessico condiviso che attraversa l’intero lavoro. private music dialoga con il passato senza indulgere in nostalgie: non cita, non rievoca, ma riarticola memorie e gesti, li ricontestualizza in un presente fatto di frammenti, glitch e sovrapposizioni. È un disco che esiste nello spazio della rete tanto quanto in quello dell’esperienza fisica, un luogo in cui l’intimità privata e la dimensione collettiva si fondono fino a diventare indistinguibili. In questo senso, il titolo stesso funziona come un manifesto: il privato non come rifugio isolato, ma come materia esposta, continuamente risignificata da chi ascolta, remixata in un processo che sfugge al controllo. Il gruppo non sembra voler esercitare un dominio sul proprio lascito; piuttosto, lo osserva farsi altro, mutare, espandersi in direzioni impreviste. private music diventa così un disco-specchio, capace di riflettere i percorsi della band e, al tempo stesso, di assorbirne la diffusione caotica nell’ecosistema culturale che li circonda.
In definitiva, private music non si limita a confermare la traiettoria dei Deftones: la ridefinisce, aprendola a nuovi spazi di senso e percezione. È un disco in cui l’intimità e la collettività si incontrano, in cui il passato si rifrange nel presente senza mai perdere la sua carica, e in cui ogni elemento — dal riff alla voce, dalla ritmica alle atmosfere psichedeliche — contribuisce a costruire un ecosistema sonoro coerente e al tempo stesso instabile. Come un rizoma che si espande, la musica si propaga oltre i confini del disco, rispecchiando la capacità dei Deftones di influenzare e contaminare, di rendere tangibile l’invisibile, di rendere pubblico ciò che era privato. È in questa tensione continua, tra controllo e abbandono, tra memoria e innovazione, che private music rivela la profondità del lascito della band e il suo posto nel contemporaneo. Come il serpente bianco che avvolge la copertina, la musica dei Deftones si riavvolge su se stessa, continua a crescere e a espandersi, tessendo nuovi circuiti di senso.