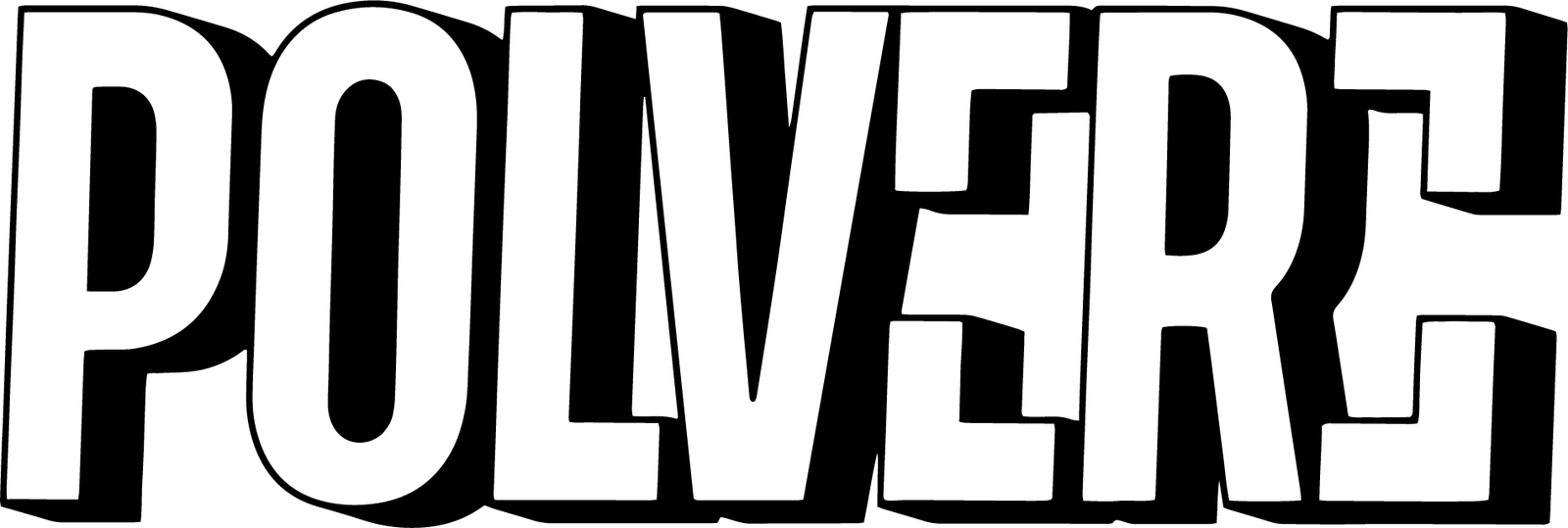Quando si parla di metalcore, l’immaginario collettivo scivola ancora verso quella melassa iperprodotta che ha infestato la fine degli anni Duemila: breakdown prefabbricati, estetica da copertina patinata, rabbia addomesticata per lo streaming. Eppure il metalcore nasce altrove, come collisione tra urgenza hardcore, estremismo grind e precisione metal, prima che l’industria lo trasformasse in formula replicabile.
In questo spazio nasce e cresce la band che da sempre si è imposta come quella che ha formato il genere e ne ha lasciato un segno indelebile. I Converge non si pongono fuori dalla scena, ma di lato. Non pionieri celebrativi, ma sabotatori permanenti. Trentacinque anni di carriera passati a rifiutare nostalgia, revival e traiettorie obbligate, più interessati a costruire relazioni artistiche – come dimostra il lavoro del chitarrista Kurt Bailou con il collettivo The Armed – che a inseguire la rilevanza algoritmica.
Love Is Not Enough, uscito il 13 febbraio, nasce da questa postura: non un disco che prova a dimostrare qualcosa, ma uno che parte da una consapevolezza. Restare necessari significa restare personali. Restare personali significa, inevitabilmente, restare scomodi. Se c’è una cosa che i Converge hanno sempre rifiutato è l’idea che l’intensità sia una posa.
Qui questa posizione diventa struttura stessa del disco. Niente introduzioni atmosferiche a fare da cuscinetto, niente concessioni alla dinamica narrativa da concept album: il suono entra subito in collisione, come se ogni brano fosse già iniziato prima ancora di essere ascoltato. È un album breve, compatto, quasi contratto su sé stesso. Non nel senso della sottrazione minimalista, ma in quello della compressione: ogni pezzo sembra esistere nella fase immediatamente successiva all’esplosione, quando l’aria è ancora irrespirabile e i detriti non hanno smesso di cadere. Nessuna ricerca dell’epica, ma della pressione. Sparisce il climax, al suo posto tensione continua.
Questa scelta emerge con forza anche nei singoli brani di Love Is Not Enough. Le tracce più veloci funzionano come detonatori immediati, costruite su ritmiche spezzate e chitarre che sembrano interessate più alla frizione che al riff memorabile. Nei momenti più lenti, invece, il gruppo evita qualsiasi deriva atmosferica: il rallentamento non serve a respirare, ma a rendere il peso ancora più tangibile. Anche quando emergono aperture melodiche, queste restano instabili, mai consolatorie, come se la band si rifiutasse deliberatamente di offrire un appiglio emotivo sicuro. Bailou, Newton e Koller (rispettivamente chitarra, basso e batteria della formazione) offrono uno spazio intersecato e strettamente proprio. Si percepisce in ogni scelta armonica e di arrangiamento che questa è la musica che vogliono fare, insieme, ibridando i limiti della musica estrema in un unicum che è quello che li ha resi l’apice di un certo approccio.
È però nei testi che il disco chiarisce davvero la propria direzione. Da sempre la band – soprattutto attraverso i versi e la voce straziata di Jacob Bannon – lavora su un dolore che non è mai soltanto individuale, o meglio che lo è di partenza. Qui la prospettiva sembra ancora più spoglia: la sofferenza non viene raccontata come crisi personale, bensì come condizione strutturale. Non è il trauma a produrre alienazione, è il mondo che la rende inevitabile. Le parole evocano perdita, disillusione, fragilità relazionale, ma senza trasformarle in estetica della vulnerabilità. Non c’è l’intimismo consolatorio che negli ultimi anni ha reso digeribile anche la disperazione dentro l’industria culturale. Qui la sofferenza non serve a creare empatia: serve a mostrare fratture. Nei testi non emerge mai l’idea che basti “capirsi” per salvarsi. Al contrario, ciò che torna è la sensazione che il legame umano, pur necessario, sia insufficiente a contrastare la violenza sistemica che attraversa il presente.
In questo senso il titolo del disco smette di suonare come un’affermazione nichilista e diventa quasi una diagnosi politica. Non è una negazione dell’amore, ma una critica alla sua retorica. In un’epoca in cui la cultura pop continua a vendere la cura emotiva come soluzione universale, il disco sembra ricordare che senza conflitto, organizzazione e trasformazione materiale, l’amore resta un sentimento disarmato. È forse proprio qui che il lavoro dei Converge oggi trova il suo peso specifico. Non nell’innovazione sonora, né nella nostalgia, ma nella postura. Se molta musica contemporanea trasforma il disagio in linguaggio condivisibile e quindi vendibile, questo disco fa il contrario: mantiene il disagio opaco, scomodo, irrisolto. Non perché rifiuti la comunicazione, ma perché rifiuta la semplificazione.
Continuare a suonare con questa intensità, dopo trent’anni, significa accettare che la musica non salva, ma può ancora impedire di assuefarsi. E forse è proprio questo, oggi, il gesto più politico possibile.