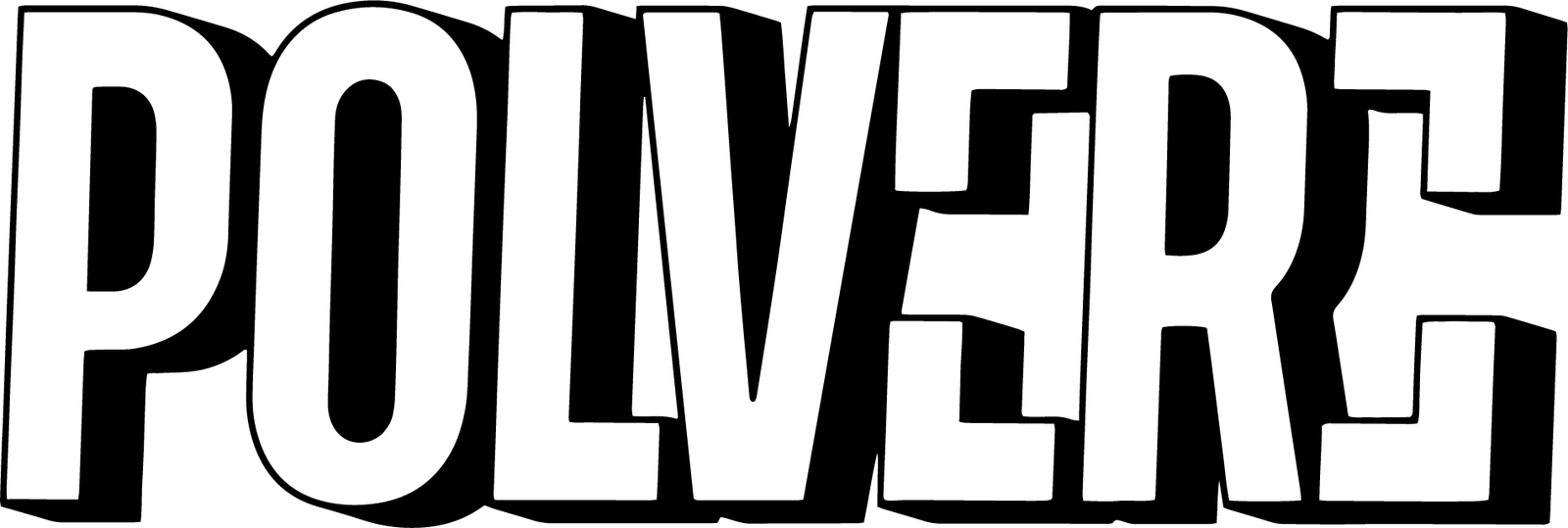Ci sono immagini che finiscono per dare nomi a un genere. Musicisti immobili sul palco, sguardo fisso sulle pedaliere, spalle curve, come se il pubblico fosse un elemento secondario. Da qui nasce il termine shoegaze, coniato inizialmente in modo ironico per descrivere una postura considerata anti-rock, distante dall’idea tradizionale di performance. Guardare le scarpe, però, non è mai stato timidezza né disinteresse. Era una necessità tecnica e, insieme, una scelta estetica. Pedali, feedback, riverberi e stratificazioni richiedevano attenzione continua. Una postura inaugurata in modo radicale dai My Bloody Valentine, che hanno trasformato la chitarra in una superficie instabile e il volume in un’esperienza percettiva più che espressiva.
In questa sottrazione di gesto e presenza si costruisce il paradosso dello shoegaze: una musica fisicamente immersiva, generata da corpi che sembrano ritirarsi. Le voci affondano nel mix, i testi diventano indistinti e proprio per questo parlano in modo più profondo. È una risposta quasi somatica a un mondo iper-razionalizzato. Un’attitudine che ha continuato a circolare anche quando il genere sembrava essersi eclissato. Negli anni ’90 questo linguaggio fu compreso abbastanza da essere rifiutato. Le critiche di NME e Melody Maker non erano frutto di superficialità, ma di incompatibilità culturale: in un’Inghilterra che si stava preparando al britpop e al ritorno dell’ego, lo shoegaze appariva introverso, opaco, poco spendibile. Più che in anticipo sui tempi, parlava una lingua laterale, inadatta a essere capitalizzata ma capace di sedimentare.

Oggi quella lingua risuona con forza perché intercetta una condizione diffusa di fatica cronica: crisi climatica, instabilità economica, guerra come rumore di fondo. Lo shoegaze non promette liberazione né rabbia. Sfugge all’inflazione del linguaggio che oggi si traduce in stanchezza semantica; è una musica che si sottrae alla richiesta di significare.
In questo modo ristabilisce un contatto con il corpo come luogo di ricezione, non di esposizione. Non è un caso che l’ascolto venga spesso descritto con metafore fisiche – annegare, essere avvolti, galleggiare – più che concettuali. Anche dal vivo accade qualcosa di anomalo: il pubblico non cerca il contatto visivo, non c’è call-and-response, l’attenzione è diffusa. È una socialità parallela, simile a viaggiare in treno di notte o a stare in acqua insieme senza parlarsi. In un mondo in cui la socialità è diventata performativa, lo shoegaze permette presenza senza prova. Il paradosso è una fusione senza fusionalità. Il muro di suono produce perdita temporanea del sé e immersione collettiva, ma senza euforia, ideologia o promessa di salvezza. Un antidoto sensoriale che ovatta e permette di disconnettersi: in passato poteva essere un lusso estetico, oggi è quasi una necessità emotiva.
Se c’è una band che mostra come lo shoegaze non sia mai davvero scomparso, ma abbia cambiato tempo e funzione, quella risponde al nome degli Slowdive. La loro marginalizzazione negli anni ’90 non fu un incidente critico, ma il segnale di uno scarto: la loro musica non rispondeva alle richieste di presenza e immediatezza del momento. L’album Souvlaki (1993) rappresenta il punto di massima definizione di questa postura. Non solo per le composizioni, ma per il modo in cui il suono diventa spazio abitabile. Il dialogo con Brian Eno non va letto infatti come una collaborazione di prestigio, ma come un passaggio concettuale decisivo. L’eredità di Eno nello shoegaze non è tanto l’uso dell’ambient, quanto l’idea che la produzione possa essere una forma di composizione emotiva.

Questa continuità non riguarda solo il passato, ma informa direttamente le forme che il genere assume oggi. A livello internazionale, lo shoegaze contemporaneo si articola più per funzioni che per stile: i DIIV lavorano sulla sottrazione, asciugando il linguaggio fino a renderlo nervoso e urbano; i Nothing ne estremizzano il peso emotivo e fisico, trasformando il muro di suono in una massa opaca e quasi claustrofobica. Sul versante più atmosferico, il blackgaze di Alcest e Deafheaven ha mostrato come l’immersione shoegaze possa reggere anche in contesti sonori radicali. Il rischio della standardizzazione esiste, ma accanto a esso cresce una produzione che usa il suono come spazio esperienziale, non come citazione.
In Italia, i Satantango rappresentano uno dei casi più interessanti proprio perché evitano sia la replica nostalgica sia l’ibridazione forzata. Il loro shoegaze lavora per densità e tensione, privilegiando immersione e opacità emotiva rispetto alla riconoscibilità immediata, e dimostra come questo linguaggio possa radicarsi anche in un contesto locale senza perdere la propria funzione. Accanto a loro, nomi come Glazyhaze e Yumeia declinano lo stesso bisogno di sospensione in forme più leggere o oniriche.
La forza attuale del genere sta anche nella tensione tra malinconia e sospensione. Gli accordi lenti e le voci sommesse radicano l’ascoltatore in un sentimento corporeo, mentre riverberi e delay dilatano il tempo e producono leggerezza. Ne nasce un piacevole disagio: emozioni profonde senza sopraffazione, vulnerabilità protetta, intimità collettiva non invasiva.
C’è una forma di radicalità nel non guardare in faccia il mondo. Chinare lo sguardo, lasciarsi avvolgere dal suono, sospendere l’ansia di apparire. In un’epoca ossessionata dalla visibilità e dalla semplificazione, lo shoegaze non è mai tornato perché non se n’è mai andato: ha continuato a circolare, a sedimentare. E proprio per questo oggi appare perfettamente allineato al presente.