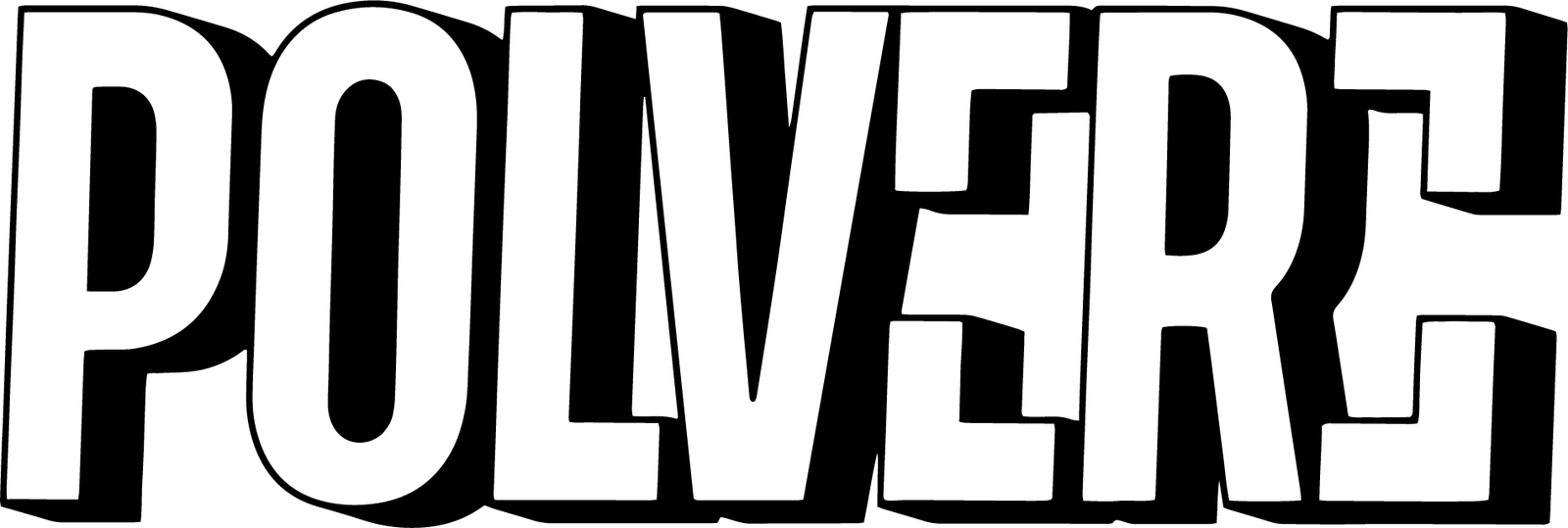Non sempre il cambiamento arriva come rottura. A volte si annuncia con un rallentamento, come se la realtà stesse trattenendo il respiro prima di cambiare configurazione. È una fase opaca, difficile da nominare, in cui le categorie abituali perdono presa ma non esiste ancora un’alternativa. Il limbo non è necessariamente una minaccia, ma resta una condizione scomoda: non offre appigli, non produce senso immediato, non permette di capire se si sta perdendo qualcosa o se lo si sta trasformando. Eppure esiste una forma di sospensione che non è paralisi ma incubazione, un luogo senza coordinate stabili in cui le cose non sono ancora ciò che saranno ma hanno già smesso di essere ciò che erano. È in questo territorio che si colloca A Hum Of Maybe, il sesto album di Apparat, alias Sascha Ring, in uscita per Mute dopo sette anni di silenzio discografico.
Il titolo è già una dichiarazione di poetica. Hum è un ronzio costante, una vibrazione che non si impone ma non scompare mai; Maybe è un forse che non coincide con l’indecisione, bensì con la possibilità. Non un aut aut, ma una simultaneità: analogico e digitale, luce e ombra, uno e zero. Ring lo descrive come uno spazio in cui le cose possono crescere e l’album sembra costruito proprio per abitare quella zona di transizione fertile. Nessuna catarsi: solo la permanenza nella domanda, dove il suono diventa un ambiente in cui sostare.
Il contesto in cui nasce rafforza questa lettura. Dopo LP5 del 2019, Ring ha attraversato un lungo blocco creativo, una fase in cui il legame con la musica sembrava essersi dissolto. Per uscirne ha adottato una pratica quasi ascetica: scrivere un’idea al giorno, senza giudizio né aspettative, accumulando frammenti imperfetti finché da quel deposito informe non hanno iniziato a emergere le forme delle nuove canzoni. Più che un ritorno all’ispirazione, è un esercizio di fiducia nel processo, un modo per accettare che la creazione nasca anche dall’indeterminatezza.
Apparat occupa da sempre una posizione eccentrica nell’elettronica contemporanea. Non è soltanto un produttore, né un cantautore tradizionale. La sua voce fragile e quasi esitante non domina il suono ma vi si dissolve, come se provenisse dall’interno delle texture: in An Echo Skips a Name il timbro emerge e si ritrae dentro un paesaggio sonoro che non lo accompagna ma lo assorbe. Anche la scrittura evita la confessione diretta: emotiva ma filtrata, personale senza diventare diaristica. Il risultato è una musica che non mette in scena l’autore ma costruisce spazi percettivi in cui l’ascoltatore può abitare.

In A Hum Of Maybe questa dimensione è amplificata dalla presenza dei suoi collaboratori storici, che trasformano il progetto in una sorta di organismo collettivo. Philipp Johann Thimm – violoncello, pianoforte, chitarra e co-produzione –, Christoph “Mäckie” Hamann – violino, tastiera e basso –, Jörg Wähner alla batteria e Christian Kohlhaas al trombone conferiscono alle undici tracce una dinamica calda e quasi cameristica, lontana dalla freddezza algoritmica spesso associata all’elettronica. Le partecipazioni di KÁRYYN in Tilth e di JanPhilipp Lorenz (Bi Disc) in Pieces, Falling ampliano ulteriormente il campo, come se il limbo evocato dal titolo avesse bisogno di più presenze per non collassare su se stesso.
Al centro dell’album c’è anche una riflessione sull’amore – per sé, per la propria compagna, per la figlia –, non come approdo rassicurante ma come forza da ricalibrare continuamente. Un sentimento che non stabilizza ma orienta, che non elimina il dubbio ma lo rende abitabile. In questo orizzonte anche uno strumentale come Enough for Me assume un valore particolare: sostiene, come una presenza silenziosa che culla senza immobilizzare e permette al movimento di continuare senza urgenza. In questo senso, il maybe del titolo non è debolezza: è la condizione necessaria perché qualcosa continui a muoversi.
L’esperienza sonora riflette questo equilibrio ossimorico. Pressione e apertura, densità e trasparenza, pulsazione e stasi convivono senza risolversi definitivamente; in A Slow Collision la tensione non esplode ma si comprime e si redistribuisce in cicli minimi, mantenendo costante una sensazione di attesa. La musica non conduce da un punto a un altro ma mantiene l’ascoltatore in uno stato di sospensione controllata, come se ogni brano fosse una stanza senza pareti completamente visibili. Non immobilità, ma movimento interno: correnti lente che modificano la percezione del tempo più che la sua velocità.
In un presente dominato dalla polarizzazione e dall’urgenza di prendere posizione, scegliere di restare nel mezzo può apparire come una fuga. A Hum Of Maybe suggerisce invece il contrario: che esista una forma di resistenza nell’accettare l’incompletezza, nel concedere alle cose il tempo di diventare altro. Il ronzio evocato dal titolo non è semplice sottofondo, ma una corrente sotterranea in cui la vita continua a scorrere anche quando non produce eventi visibili. È lì che si accumulano le trasformazioni più profonde, lontano dalle svolte apparenti e dalle decisioni definitive. Non tutte avvengono nel momento della scelta; molte accadono mentre restiamo sospesi, mentre impariamo a tollerare l’assenza di forma senza smettere di muoverci. In questo senso, il limbo non è un vuoto da colmare ma uno spazio da attraversare. Forse il solo in cui qualcosa di davvero nuovo può prendere consistenza.