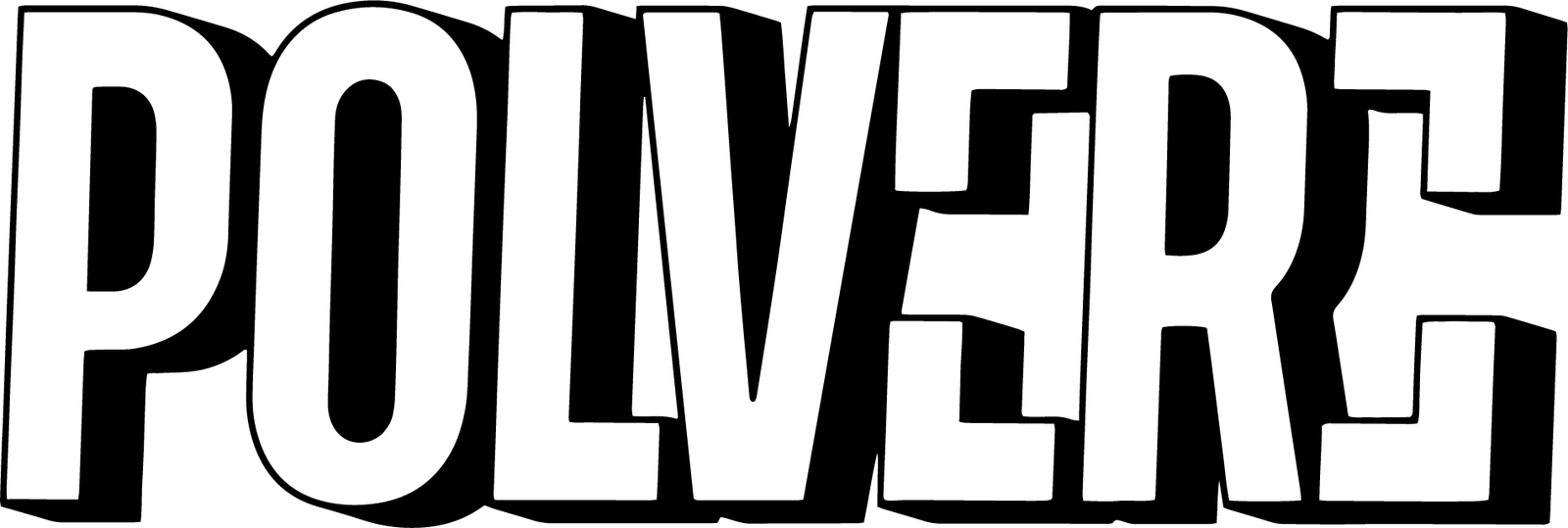Se pensiamo, all’interno della musica contemporanea, a chi negli ultimi quindici o vent’anni ha dettato delle regole così fondanti per tutto ciò che è venuto dopo, portando un approccio di nicchia a diventare la norma, probabilmente il nome che staccherebbe di tanto altri validissimi contendenti è quello di Tame Impala e della persona dietro il progetto: il compositore e cantautore australiano Kevin Parker. Il suo metodo ha scritto delle regole, posto delle consuetudini sia nella produzione musicale che nell’ascolto: ha portato l’approccio archivistico della library music alle masse, ha rilanciato in modo sensibile una psichedelia trasversale che si svincola dai confini di genere, suggerendo la necessità di riferirsi in modo onnicomprensivo ai propri ascolti e, di conseguenza, a ciò che si crea.
Ognuno dei lavori che portano quella firma, dal 2010 in poi, ha generato intorno a sé qualcosa che solo le menti artistiche capaci di leggere e leggersi riescono a produrre. Tame Impala ha sempre spinto chi ascolta a esplorare, a entrare nei meccanismi creativi di Parker, risalendo alle influenze, alle suggestioni e ai paesaggi sonori che li compongono. Orizzonti contemporaneamente unici e universali. Negli anni, la figura dell’artista e quella del suo alter ego hanno intrecciato la storia del nerd introverso e del guru di culto, generando cortocircuiti di senso che, fino a oggi, mantenevano una loro coerenza e una certa dignità, anche quando Parker spalancava le barriere, arrivando a collaborare con realtà musicali apparentemente opposte a lui. Dentro Tame Impala coesistono da sempre le contraddizioni che rendono il mercato musicale contemporaneo quello che è: un’altalena in cui ricercato e vendibile sono confini sfumati, dove anche la nicchia diventa argomento commerciabile perché intercetta le tendenze. Poli opposti che col tempo sono diventati anche la chiave di lettura per comprendere la persona dietro la musica. Parker ha incarnato una dicotomia evidente tra artista trendy e sociopatico, tra chi detta legge e chi si sente ai margini. E, fino al suo ultimo album, a questa cosa si poteva credere.
In Deadbeat, invece, l’equilibrio si sfalda. È un castello di carte, tenuto insieme solo dall’ego di chi lo compone e quell’ego stride con i temi musicali e lirici che vorrebbe imbastire. Il percorso che ha portato Tame Impala a diventare un fenomeno di massa è sempre stato contraddistinto da una certa credibilità. Era facile comprendere le intenzioni di Parker, leggerle in chiave autobiografica e rapportarle a un’evoluzione personale che, pur nella sua esibita introversione, risultava autentica. In Deadbeat questo legame si spezza: il disco è pieno di riferimenti al fallimento e all’inadeguatezza, ma suona come un esercizio di autocommiserazione da parte di chi non sembra più disposto a farsi davvero attraversare da ciò che racconta.
I testi, disseminati di frasi che tornano ossessivamente sul tema della distanza da sé, della colpa e dell’incapacità di cambiamento, rivelano più un manierismo che una crisi. È come se Parker tentasse di recitare il ruolo dell’outsider, ma la parte non gli riuscisse più credibile. La voce del perdente di successo che dice di non farcela mentre vive nel comfort del proprio mito suona stonata, soprattutto quando viene accompagnata da produzioni grandiose, pulitissime, pensate per un pubblico che balla più che per uno che ascolta. Sul piano sonoro, Deadbeat è un disco che oscilla in modo goffo tra nostalgia e strategia. Le batterie elettroniche e i bassi pulsanti vorrebbero rievocare la trance dei bush doof, i rave australiani che Parker ha citato come ispirazione, ma la resa è patinata, quasi da simulacro. Si percepisce la volontà di evocare un’esperienza collettiva e liberatoria, ma la costruzione dei brani rimane confinata a un livello cerebrale, come se il suono stesso fosse una citazione più che un’esperienza. La psichedelia che un tempo era flusso ora è ornamento, compressa dentro arrangiamenti rigidissimi, con drop e aperture pensate per il formato digitale.
Le melodie, spesso lineari fino all’anonimato, non riescono a sostenere il peso concettuale che Parker vorrebbe dargli. Quando in passato la semplicità melodica era un modo per aprire porte emotive, qui diventa solo ripetizione, schema. Le voci trattate, i falsetti e i riverberi sembrano citazioni di sé stessi, eco di un suono che Parker ha reso popolare ma che ora fatica a rinnovare. I momenti in cui il disco tenta la via dell’astrazione – le tracce più lunghe, più ambientali – vengono interrotti da ritornelli pensati per l’ascolto immediato. La tensione che un tempo definiva Tame Impala, quel continuo spostamento tra intimità e grandiosità, qui collassa in un’ambiguità senza direzione. Negli anni Parker è passato dall’essere un outsider del rock psichedelico a un produttore e autore richiesto nel pop mainstream. Ha lavorato con Lady Gaga, The Weeknd, Dua Lipa, Rihanna, Mark Ronson. Collaborazioni che hanno mostrato la sua abilità tecnica e la sua naturale inclinazione a cercare la perfezione, ma che lo hanno anche avvicinato a un linguaggio che mal si concilia con la sua immagine di figura introversa e solitaria. Quella transizione, che un tempo appariva come un ponte tra due mondi, oggi sembra averlo inghiottito del tutto. Deadbeat suona come un album in cui l’artista tenta di riaffermare la propria vulnerabilità dopo averla smarrita nel successo, ma lo fa con strumenti che la neutralizzano.

La retorica del non appartengo a questo mondo non funziona più se chi la pronuncia è ormai un pilastro del pop mondiale. Eppure Parker sembra convinto che basti evocare la propria insicurezza per restituire autenticità al progetto. In realtà, ogni elemento del disco – dai testi alla produzione, fino all’immagine promozionale – è filtrato da un controllo quasi ossessivo che tradisce la paura di perdere rilevanza. L’autoanalisi si trasforma in branding, l’insicurezza in estetica. Anche il richiamo ai rave australiani appare più come un espediente narrativo che come una reale immersione culturale. Parker ha parlato di voler catturare l’energia dei doof, ma quello che ne rimane è un simulacro levigato, pensato per chi il rave lo consuma come immaginario e non come esperienza. Non c’è la dimensione comunitaria, la fisicità, la perdita del controllo che definiscono quella cultura: solo il suo suono semplificato e sterilizzato. L’appropriazione di quel linguaggio si riduce così a un vezzo, a un modo per rivendicare una radice alternativa ormai inesistente.
Deadbeat è un disco che perde di vista il proprio centro. Ogni brano sembra costruito su un’idea di grandezza che non riesce mai a concretizzarsi. È pieno di momenti in cui si intravede la vecchia brillantezza – un passaggio armonico, un dettaglio di batteria, un break che apre uno spiraglio – ma sono istanti che svaniscono subito, soffocati da un’eccessiva lucidità produttiva o da una retorica vuota. Quello che manca, più di tutto, è una direzione: non nel senso di un genere o di una formula, ma di un gesto. Parker sembra paralizzato tra il desiderio di reinventarsi e la paura di deludere le aspettative di chi lo considera un genio. È un album che parla di smarrimento, ma non riesce mai a incarnarlo; parla di cadute, ma non rischia mai davvero di cadere.
Deadbeat è, forse, il primo vero passo falso di Tame Impala. Non tanto per mancanza di idee, quanto per un eccesso di consapevolezza. Parker ha sempre fatto della riflessione su se stesso un motore creativo, ma questa volta la riflessione ha divorato tutto il resto. Il risultato è un disco che guarda indietro senza più nostalgia, avanti senza curiosità, e dentro di sé senza trovare nulla. Un lavoro che suona come un tentativo di restituire significato a un mito che non si sa più da che parte stia.