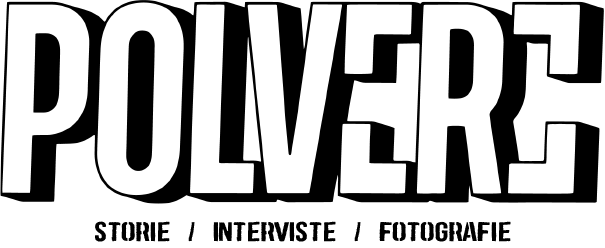Alla sua prima esperienza con un disco autoprodotto, St. Vincent torna alle sonorità introspettive che hanno caratterizzato i suoi primi lavori, ritinteggiandole in chiave notturna. Si riconferma, ancora una volta, il genio creativo di Annie Clark
«Una tazza vuota, un barattolo pieno di calendule, una candela mezza bruciata; lettere, documenti e cenere su linoleum». Comincia così, avvolto dalle diapositive di una narrazione stanca e consumata, l’ultimo viaggio di St. Vincent: «una lunga passeggiata nel bosco da soli», come lei stessa lo ha definito. Un itinerario sonoro a metà strada tra l’onirico e l’oscuro, l’etereo e il distorto. È «l’inizio – ci anticipa Annie Clark –. Il nostro inizio, ricominciare».
Ed è davvero un nuovo inizio, anche al di fuori della narrazione. Infatti, a tre anni da Daddy’s Home, l’ultima perla – scusate se mi sbilancio – della polistrumentista americana, All Born Screaming è il primo disco interamente autoprodotto. Per l’occasione, l’artista torna alle sonorità dei suoi esordi, più introspettive e crepuscolari rispetto agli ultimi lavori, differenziandosene ancora.
Del resto, nell’annunciare l’album per la prima volta, la stessa Clark lo ha definito il frutto di una necessità, del «bisogno di andare più a fondo nella ricerca del proprio vocabolario sonoro». Una frase, questa, che ben descrive non solo l’ultima tappa del suo percorso artistico, ma l’intera sua carriera musicale, caratterizzata da una vasta sperimentazione sonora, da una raffinata sintesi d’ispirazioni variegate e da una cura maniacale negli arrangiamenti, perfettamente bilanciati nella loro complessità.
E da questo punto fermo inizia, tra tamburi e riverberi, Hell Is Near, la prima traccia di All Born Screaming. I rimandi sono molti e molto diversi tra di loro: l’ingresso della sezione ritmica, sulla dispersione aurea di un synth immerso nel riverbero, ricorda i Radiohead di A Moon Shaped Pool; la scala minore melodica della chitarra elettrica arabeggia arpeggi dal sapor di System Of A Down.
Con Broken Man – primo singolo estratto dall’album, dal cui videoclip è stata presa l’immagine di copertina – si ha un improvviso cambio di rotta in questa nostra passeggiata. La terra sotto i piedi si assottiglia, si fa sabbia: ci troviamo nelle terre desertiche della California, patria nativa dello stoner. Non è un caso, infatti, che la batteria sia qui affidata a Dave Grohl che in quelle terre la fa da padrone, seduto sul trono accanto a Josh Homme, leader dei Queens of The Stone Age. Qui, la ritmica comincia a farsi più incalzante, schematica. Il nervosismo emerge a fior di pelle e il drive delle chitarre fa vibrare le fondamenta – quelle rimaste ancora in piedi, sotto il percuotere del vecchio Dave –.
Gli arrangiamenti si riconfermano il punto forte di St. Vincent, accanto ai riff ricercati che seducono l’udito senza risultare mai banali: si annidano nella testa malgrado gli accenti dispari e le note dissonanti. Fraseggi di chitarra, di sintetizzatore, di fiati e di basso duettano tra loro, perfettamente complementari nella loro fondamentale differenza. Annie Clark ha la capacità, come pochi altri, di giocare a mischiare canoni stilistici anche molto distanti tra di loro, sintetizzandoli in un nuovo linguaggio espressivo, originale e personale.
Big Time Nothing si offre come un perfetto esempio di questa capacità. Le chitarre distorte si alternano ai sintetizzatori, al basso in wah wah, ai fiati asciutti – che sembrano usciti da un videogioco degli anni ’90 – e a una chitarra funky che, di tanto in tanto, si distende sullo sfondo: il tutto, sopra il tappeto ritmico di un synth modulare – che riecheggia Army Of Me di Björk – fluido, ma dal groove virtuoso e incisivo. In Violent Times – tra le tracce più riuscite del disco – lo shuffle della batteria si prende il suo spazio, rimbombando sulle pareti; i fiati, tra sobbalzi e distensioni, si esprimono in un linguaggio epico; le chitarre arpeggiano, eteree, trasferendo il tutto su una dimensione onirica.
Con la title track, alla quale viene affidato il compito di porre fine al viaggio, si interrompe l’atmosfera cupa e sognante che contraddistingue il disco, almeno in un primo momento. Le chitarre saltellano gioiose su ritmiche in levare che lasciano intravedere l’influenza artistica di David Byrne, cicatrizzata dall’ormai lontana collaborazione in Love This Giant. In chiusura, si entra in un tunnel di echi fantasma, di riverberi e cuori pulsanti, sorretto solo dalla batteria di Stella Mozgawa finché Cate le Bon, al basso e alla voce, ci indica la luce sullo sfondo, accompagnandoci verso l’uscita.
Quello che resta, alla fine del viaggio, è una collezione di impressioni variegate, sonorità variopinte e immagini crepuscolari. All Born Screaming è un album accuratamente bilanciato, tra ispirazioni oltre i generi e sperimentazione sonora. Ribadito il proprio genio creativo, St. Vincent dimostra – producendosi da sola – che il suo sound è solo suo, che l’asticella resta alta e che, soprattutto, non ha bisogno di nessuno.