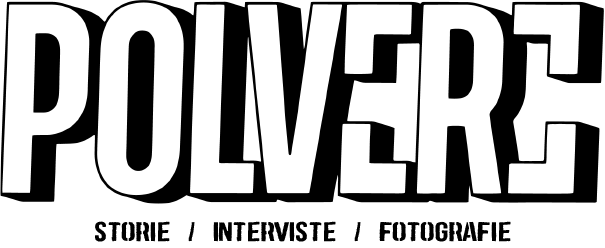Siamo sinceri: quando pensiamo alla Turchia, l’ultima cosa a cui ci capita di pensare è la sua scena musicale underground. Vuoi perché la storia dell’Anatolia è, già di suo, così interessante e straripante; vuoi perché l’esportazione del grunge turco nel mondo è stata soppiantata da quella del Döner industriale o vuoi perché – purtroppo – molte volte le nostre mappe mentali ci convincono aprioristicamente che da un determinato territorio non possa uscire niente di particolarmente buono a livello musicale. E non è certo il caso della musica underground turca
La chiave per comprendere questa assurda scena musicale alternativa – che parte dai vecchietti con le barbe lunghe che suonano lo saz e arriva ai duo hip hop-germany-based composti da ragazzini di origine turca che parlano di droga e di voler bruciare le macchine degli sbirri – è solo una: melancolia.
Questa è una di quelle parole che, a seconda del contesto, può significare diecimila cose diverse: dall’aumento della bile nera nel nostro corpo al potente collegamento tra genio e la sua energia creativa. Con l’avvento della cultura occidentale e della psicologia come scienza propria, questo termine ha finito con l’assumere il significato di una specie di tristezza motivata dal fatto che sentiamo la mancanza di un passato idealizzato che però non abbiamo mai avuto modo di vivere realmente.
Se applicato al contesto turco, però, questo termine assume un altro significato. O meglio, il significato resta più o meno lo stesso. È il piano che si sposta. Lo scrittore Orhan Pamuk, infatti, definisce la hüzün – parola con cui si indica la melancolia in turco – come un sentimento non più individuale ma collettivo: è lo stesso popolo turco a vivere in una costante condizione di melancolia dettata dai continui e repentini cambiamenti che hanno riguardato il paese nell’ultimo secolo.
 La traduzione musicale dell’hüzün arriva all’inizio del 1950 con il genere Arabesk che, sostanzialmente, non è altro che la fusione tra il folk tradizionale turco, alcuni elementi della musica occidentale e pure un pizzico di danza del ventre egiziana. L’Arabesk, però, rappresenta anche un vero e proprio stato mentale: Arabesk è l’immigrazione dalle campagne all’interno della metropoli; Arabesk sono i bicchieri di raki e le mille sigarette fumate in una bettola decadente alle porte di Istanbul; Arabesk è la continua solitudine, indomabile e allucinatoria; Arabesk è il grido della classe operaia turca e, in quanto tale, avversato dalla classe dominante.
La traduzione musicale dell’hüzün arriva all’inizio del 1950 con il genere Arabesk che, sostanzialmente, non è altro che la fusione tra il folk tradizionale turco, alcuni elementi della musica occidentale e pure un pizzico di danza del ventre egiziana. L’Arabesk, però, rappresenta anche un vero e proprio stato mentale: Arabesk è l’immigrazione dalle campagne all’interno della metropoli; Arabesk sono i bicchieri di raki e le mille sigarette fumate in una bettola decadente alle porte di Istanbul; Arabesk è la continua solitudine, indomabile e allucinatoria; Arabesk è il grido della classe operaia turca e, in quanto tale, avversato dalla classe dominante.
Non è quindi certamente un caso se la storia di questo genere sia stato spessa messo in relazione con la nascita della cultura punk in Inghilterra. Nonostante la differenza cronologica, infatti, l’origine e le tematiche affrontate dall’Arabesk sembrano molto simili a quelle partorite dalle periferie inglesi circa vent’anni dopo. Classe operaia, alienazione, abuso di sostanze, critica al pensiero dominante e nichilismo estremo: verrebbe quasi da dire che quei signori con i baffoni pronunciati, che suonano quegli strani strumenti di legno, siano stati i genitori putativi dei giovani con creste e chiodi che sputavano sulle vecchie a Portobello Road.
A differenza del punk occidentale, però, l’Arabesk non ha un bersaglio preciso: se il primo adorava scagliarsi – almeno in origine – contro tutto ciò che poteva rappresentare un qualsiasi tipo di potere, la musica turca si mostra volontariamente meno politica: se si è costretti a lavorare 14 ore in una fabbrica puzzolente per guadagnare una cifra che non basta nemmeno a garantirsi un pasto decente, la colpa non è della società, del governo o, tantomeno, del capitalismo. Se si vive nel completo disagio e senza una prospettiva futura, la colpa è principalmente del destino. Un fatalismo nichilista scuro come il fondo del caffè turco.
Se il contesto in cui nasce teorizza un approccio alla vita che farebbe prendere male anche Giuseppe Verga, si potrà facilmente intuire che la produzione musicale underground contemporanea turca continua certamente a non essere la cosa più allegra del mondo.
 Il primo gruppo che merita di essere segnalato sono gli Hedonistic Noise. Composto da “tre pezzi” provenienti da Istanbul, questa band suona un punk strano che sprizza disperazione da tutti i pori. Dimenticate le sonorità provocatorie del punk rock e immergetevi in una realtà fatta di disperazione e annichilimento, come testimoniano anche i principali titoli delle canzoni e degli album – tradotti con Google Traduttore –: morire, passato, errore, dannazione e buco-di-culo-da-cui-esce-la-merda. Anche la grafica scelta per rappresentarsi sembra risentire a pieno della hüzün turca, dal bambino che gioca in mezzo agli alberi tra cui sta appostato il protagonista de L’Urlo di Munch a figure antropomorfe che si sbranano tra di loro e/o piangono lacrime nere. Se siete troppo allegri e volete rovinarvi la giornata con un gruppo musicalmente forte, forse l’album intitolato Selezione naturale è quello che fa per voi.
Il primo gruppo che merita di essere segnalato sono gli Hedonistic Noise. Composto da “tre pezzi” provenienti da Istanbul, questa band suona un punk strano che sprizza disperazione da tutti i pori. Dimenticate le sonorità provocatorie del punk rock e immergetevi in una realtà fatta di disperazione e annichilimento, come testimoniano anche i principali titoli delle canzoni e degli album – tradotti con Google Traduttore –: morire, passato, errore, dannazione e buco-di-culo-da-cui-esce-la-merda. Anche la grafica scelta per rappresentarsi sembra risentire a pieno della hüzün turca, dal bambino che gioca in mezzo agli alberi tra cui sta appostato il protagonista de L’Urlo di Munch a figure antropomorfe che si sbranano tra di loro e/o piangono lacrime nere. Se siete troppo allegri e volete rovinarvi la giornata con un gruppo musicalmente forte, forse l’album intitolato Selezione naturale è quello che fa per voi.
Diversi come sonorità sono i Kaptan Kadavara – la traduzione è esattamente Capitano Cadavere – che propongono una sorta di doom metal inframmezzato da melodie tipiche del folk turco. Se a Istanbul splende ancora qualche raggio di sole, ad Ankara piove ormai da millenni visto che, anche in questo caso, l’allegria sembra un sentimento sconosciuto. Il quintetto turco arriva alle orecchie pesante come un macigno e tagliente come un kilij affilato. Il gruppo sembra anche celare uno strano feticismo per i bulbi oculari, visto che tre album su quattro riportano raffigurazioni di occhi strappati e messi in posti a caso, come sulla fronte di una testa composta da vermi.
 I Kozmik Yıkım sono, al contrario, la testimonianza che se si viene da una scena che fa della presa a male il proprio cavallo di battaglia, per quanto ci si possa sforzare di fare roba diversa, alla fine si rimane sempre lì, attaccati al proprio scoglio. Nonostante provi ad essere un po’ più ottimista – almeno nella sonorità – questo gruppo alternative punk di Istanbul è un distributore automatico di melancolia. E il fatto che l’intento non sia dichiarato rende tutto ancora più difficile.
I Kozmik Yıkım sono, al contrario, la testimonianza che se si viene da una scena che fa della presa a male il proprio cavallo di battaglia, per quanto ci si possa sforzare di fare roba diversa, alla fine si rimane sempre lì, attaccati al proprio scoglio. Nonostante provi ad essere un po’ più ottimista – almeno nella sonorità – questo gruppo alternative punk di Istanbul è un distributore automatico di melancolia. E il fatto che l’intento non sia dichiarato rende tutto ancora più difficile.
Per chiudere questo breve racconto, tra le tantissime band che meriterebbero di essere menzionate, non si può non citare quella col nome in francese. Se infatti decidi di chiamarti Plein De Vie devi assolutamente soddisfare le aspettative e suonare una musica che infonda la voglia di morire. Obiettivo pienamente raggiunto dal quartetto screamo di Ankara. Oltre al suono davvero pesante, complice il muro di amplificatori Orange che si scorge da alcune foto dei live, la voce dei “Pieni di vita” è, al contrario, una sorta di pianto disperato continuo che maledice ogni secondo della nostra esistenza.
Morte, allucinazioni, stanchezza di vivere, depressione, abusi e sfruttamento. Questi sono gli elementi che caratterizzano l’immaginario della scena musicale underground turca, una realtà che si è spesso trovata sbattuta e disorientata tra sconvolgimenti storico-sociali e che, da questi sconvolgimenti, ha saputo trarre un genere che, nel suo nichilismo estremo, racconta storie di periferie, degrado e impossibilità di sentirsi a casa all’interno di un mondo che, volenti o nolenti, ti farà sentire per sempre un estraneo. Perché, nel suo nichilismo estremo, la scena underground turca racconta la storia dell’esercito di sfruttati che ha, nei fatti, versato sangue, sudore e lacrime per provare a cambiare la propria condizione.