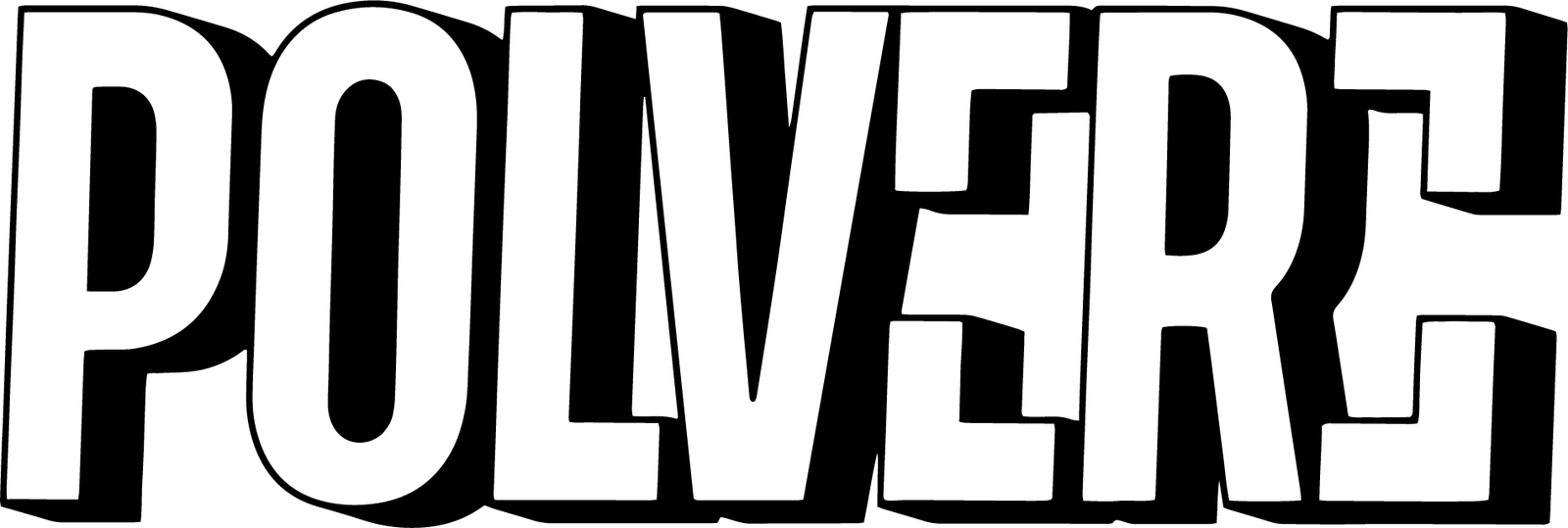Giovedì 7 agosto, primo giorno di Ypsigrock 2025. Per le strade c’è già quella strana atmosfera magica che è un misto tra scorci di “vita lenta” e caos organizzato. Un sole implacabile rimbalza sulle pietre di Castelbuono, in piazza e nel chiostro si respira quell’aria sospesa che il festival sa creare come pochi altri in Italia. Il borgo, stretto tra le Madonie e un mare che si intuisce appena, diventa uno spaccato fuori dal tempo: gli anziani fuori dai bar insieme a echi di soundcheck in lontananza, con un miscuglio di lingue che ricorda che qui, arrivano da tutta Europa. Dopo solo un’ora, le strade si riempiono a ondate, la piazza rimbomba di chiacchiere, birre che si incontrano a metà strada e borse di tela che sbattono sulle gambe. Il sole filtra tra i vicoli musicati da playlist tematiche, come se il festival permeasse tra le fessure delle case, fino a riempire l’intero paese e diventare una cosa sola.
Quest’anno, già dal pomeriggio, L’Ypsi & Love Stage al Chiostro di San Francesco si trasforma in un microcosmo visivo e sonoro. Le prime note arrivano dai componenti di The Sound of This Place 2025, una premiere esclusiva della residenza artistica di quest’anno. Massimo Silverio, Tara Nome Doyle e Priyaji creano un panorama elettronico leggero, intrecciando violoncello, Fender Bass VI, synth mistici e ritmi tribali su trame vocali armonizzate e sognanti. L’atmosfera è stata potenziata da cinque piccoli schermi LED, piazzati con discrezione ma capaci di amplificare il senso di immersione. Sullo sfondo, le immagini curate da Martin Romeo (anch’egli parte del progetto): un viaggio nella natura suggestivo e profondo, che aiuta a entrare nello show. Mentre l’impianto cerca di farsi strada sopra il brusio delle ultime file, una lingua ignota tra il carnico e l’inglese prende spazio dove concesso e conquista chiunque la voglia accogliere.

Con gli Offlaga Disco Pax, si respira aria di sinistra anche sotto le pietre. Sugli schermi solo il logo storico della band, vicino, una bandiera della Palestina che pende da una finestra del Chiostro. Le parole di Max Collini si infilano tra le arcate come volantini clandestini: racconti di tempi che per qualcuno sono ricordo vivido, per altri scoperta in presa diretta. È la celebrazione di un gruppo che ha segnato la storia di un’Italia impegnata, quella che non si è mai arresa e che continua a resistere davanti a una destra sempre più ingombrante e nostalgica.
La formula è quella di sempre, e funziona: atmosfere elettroniche, sequenze di drum machine, un basso new wave di Mattia Ferrarini e chitarre shoegaze che Daniele Carretti lascia fluttuare in un riverbero senza fretta. La voce di Collini declama testi con uno spoken calibrato al millimetro, trasformando ogni brano in un cortometraggio di memoria personale e politica. Verso la fine, il cambio di passo: i bpm si alzano e l’aperitivo musicale si trasforma in antipasto verso il main stage.
Dopo una breve attesa, sull’Ypsi Once Stage salgono i Maruja, quartetto di Manchester formato da Harry Wilkinson alla voce e chitarra, Matt Buonaccorsi al basso, Joe Carroll al sassofono e Jacob Hayes alla batteria. Sempre presente e svolazzante, sul palco troneggia una bandiera palestinese, che i ragazzi ci tengono a omaggiare più volte, ricordando a tutti del genocidio in corso. Dopo le prime canzoni sembra di vedere i Rage Against the Machine sotto acidi: groove mastodontici, trainati da una sezione ritmica aggressiva, mentre il sax disegna linee che da ipnotiche diventano stridenti, come se contenessero l’energia di un intero stadio.
Harry alterna rap serrati a frasi ripetute e urlate. Quando prende in mano la chitarra, però, la situazione si fa più complessa. Il live vira verso un’improvvisazione free jazz che fa da trampolino a un climax guidato da un discorso infuocato, culminante in un’esplosione sonora che fa partire i primi poghi della serata. Tra vocalizzi arabeggianti e incursioni di Joe in mezzo al pubblico, la folla diventa un corpo unico, divisa fisicamente fino al mixer per poi essere risucchiata in un pogo brutale. Post-punk, hardcore, echi mediorientali: Piazza Castello è già gremita, cosa rara per i primi artisti in scaletta. A fine scaletta, il parterre entusiasta urla «One more song!», ma il tempo stringe e devono salutarci: un’apertura da manuale.
Sul palco, Carpetman si presenta con un assetto minimale: tre figure che, pur senza presentazioni formali, si muovono come un organismo unico. Al centro, la voce magnetica e diretta alterna toni narrativi a slanci emotivi, con un falsetto talmente convincente da sembrare un duetto maschile e femminile intrecciato nella stessa gola. Alla sua sinistra, un chitarrista ricama arpeggi scintillanti e accordi sospesi; alla destra, dietro una console costellata di synth e controlli, il terzo membro costruisce trame elettroniche e sequenze ritmiche dal respiro ipnotico. L’atmosfera chill e sensuale avvolge la piazza in un velo di morbidezza. Dopo la prima canzone, il cantante rompe il ghiaccio in italiano: «Se vi riconoscete in questo personaggio, allora tutto sta andando secondo i piani». Il pubblico sorride e annuisce, pronto a lasciarsi trasportare. Il set è un mosaico di beat lo-fi hip hop, elettronica alternativa e drop con bassi profondissimi, da far vibrare i sampietrini.
Sul fondo del palco, un visual caleidoscopico amplifica l’esperienza, sposandosi perfettamente con i costumi di scena: vestaglie cucite con tappeti e maschere di tessuto dai pattern colorati. Con il passare dei brani, però, la formula inizia a mostrare qualche ripetizione: bpm e struttura tendono a ricalcarsi, i drop “da TikTok” diventano prevedibili, un marchio tanto efficace quanto limitante. Il trio chiude il set senza saluti né ringraziamenti, forse a causa di un problema tecnico al computer. Non il massimo, soprattutto considerando l’esibizione precedente e quella successiva.
Infatti, con le Lambrini Girls, il pit si trasforma. Il duo di Brighton scuote le masse come un uragano, il cui motore è l’instancabile Catt White dietro ai fusti. La prima canzone è un’onda sonora così densa che le note si perdono, ma è chiaro che qui conta soprattutto l’impatto fisico. Phoebe Lunny interrompe il pezzo a metà per aprire un cerchio della morte, mettendo subito in chiaro che per loro la risposta del pubblico è fondamentale. Il basso di Lilly Macieira è così distorto da distruggersi tra una plettrata e l’altra, mentre Phoebe urla instancabilmente. La band spara a zero su tutto e tutti, facendo uscire la loro anima da agitatrici di masse: attaccano il governo, accusano la Meloni, parlano di genocidio e intonano cori pro-Palestina. Se i Maruja mischiavano groove e rabbia, loro sono una mitragliatrice punk. La loro energia è uno tsunami che colpisce la folla, la mischia, la agita e la fomenta.
Con bpm altissimi e poghi continui, incitano cori «ACAB» su Bad Apple e attaccano frontalmente J.K. Rowling dopo un discorso sui diritti trans e non-binary. Solo in Craig David, Lilly posa il basso e gioca coi pedali, mentre Catt dimostra che può reggere tutto da sol*. Verso fine live Phoebe fa abbassare tutti, aizzando un climax di botta e risposta in cui il pubblico risponde al suo «Fuck» con «Meloni», che cresce da un sussurro fino a diventare un urlo da stadio. Chiudono quello che è forse il live più memorabile della serata con Cuntology 101, cantata come un karaoke su base. Zero compromessi, zero mezze misure.

Durante il cambio palco per Lucio Corsi, noto che il pubblico si è trasformato in un patchwork improbabile: bambini e famiglie si mescolano a giovani sudati ed euforici che prendono fiato dal pogo post-Lambrini Girls, creando un’antitesi linchiana quasi comica. Sullo sfondo, un telone gigante raffigura la tastiera di un pianoforte che scende a spirale dalle nuvole; sul palco, sette musicisti: Lucio, altre due chitarre (acustica ed elettrica), basso, batteria, organo/synth e piano. C’è meno entusiasmo rispetto agli altri set: il pubblico appare teso e l’artista un po’ distante. L’arrivo in pompa magna non aiuta a creare empatia, e l’aura da rockstar sembra funzionare solo con i fan più giovani. Le armonizzazioni a tre chitarre sono impeccabili, le canzoni fiabesche e bizzarre conquistano un pubblico eterogeneo, che le accoglie più come uno spettacolo teatrale che come un concerto.
L’ibrido tra cantautorato e glam rock convince per metà: i testi, frutto di folgorazioni poetiche bellissime e affascinanti, si accompagnano a soluzioni musicali un po’ troppo macchiettistiche, di un genere che sembra ripetuto ed emulato senza sforzi di svecchiamento o rielaborazione. La presenza scenica di Lucio è quella di un circense: si cambia d’abito, si trasforma ed evolve canzone dopo canzone, ma fuori da queste performance poco altro accade. Poca improvvisazione, niente sorprese; ogni brano è riprodotto fedelmente e con cura, tanto da far sembrare l’esibizione un po’ troppo impacchettata. Arrivando dallo “stesso campionato”, Colapesce e Dimartino l’anno scorso avevano giocato di più, portandosi a casa un risultato più caldo anche dal lato umano, insieme a uno spettacolo di luci e visual emozionante. Qui, invece, il famoso rock’n’roll sembra filtrato dall’immaginario dei bambini: stereotipato, confezionato.
La sua hit Volevo Essere un Duro, inno alla normalità e alla fragilità, si scontra con uno spettacolo in cui l’eterno Peter Pan sembra voler convincere tutti di essere una rockstar. La percezione è quella di un live troppo studiato, fuori dal contesto di un cantautore eccellente che, nella sua semplicità, ha sempre saputo conquistare tutti, senza voler essere per forza qualcos’altro.
Così si chiude il primo capitolo di Ypsigrock 2025: un pomeriggio partito in punta di piedi tra pad eterei e immagini di boschi, passato per marce politiche in 4/4, drop da TikTok, poghi infiniti e dichiarazioni incendiarie, fino ad arrivare alle favole di Lucio Corsi sotto un cielo stellato. Tra gli artisti e il pubblico, l’intesa è quella giusta: si cerca un cambiamento politico, sociale, civile, con un po’ di rabbia in più, con una partecipazione che mi fa sperare. E siamo solo all’inizio.
Nota a margine: Come accennato nel sommario in apertura, l’energia di questo inizio crea una spaccatura, concretizzata anche dal fatto che Giorgia Mirabile (la nostra fotografa) ha rotto la lente dell’obbiettivo appena prima dell’inizio dei concerti. Quindi, per coerenza, o forse per destino, avrete foto letteralmente frammentate.