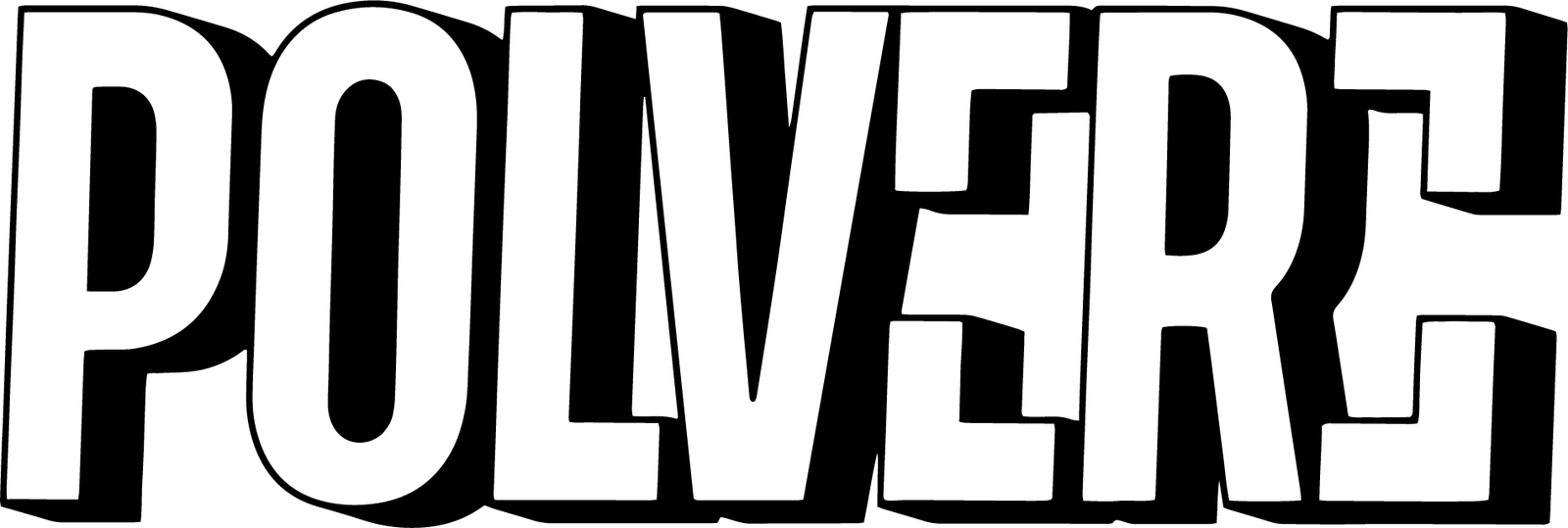Se c’è stata una difficoltà, come ascoltatrice in questi ultimi mesi, è quella di non essere riuscita ad affezionarmi a molte delle promettenti band emergenti in uscita. Nel 2025 il sottobosco rock alternative ci ha messo sul tavolo moltissime scelte musicali, tutte osannate dai giornali, ma il cui ascolto sembra sempre esaurirsi in massimo quattro tracce, dando l’impressione di aver ascoltato sempre la stessa canzone per quaranta minuti.
I Coach Party si stagliano in questo panorama musicale che sa già di saturazione, ma in cui allo stesso tempo sembra volerci ben poco per potersi differenziare. I quattro isolani dell’Isola di Wight, compaesani dei loro colleghi Wet Leg, non sembrano avere abbastanza giustizia nella critica musicale odierna, tant’è che il loro secondo lavoro, Caramel rischia di perdersi nell’algoritmo nonostante la potenza visiva e musicale che i nostri sono riusciti a creare.
Caramelè un susseguirsi ininterrotto di dieci tracce, prive di filler inutili e pigri, che si legano dolcemente l’un l’altra per raccontarci i cambiamenti e le speranze del mondo che viviamo oggi. Killjoy, il loro primo album, era intriso di disperazione apocalittica, complice forse l’uscita del disco appena dopo la fine della pandemia. In questo primo lavoro, il gruppo portava l’esperienza della solitudine su musica, nascondendo dolori e richieste di affetto quasi imperative dietro l’ironia punk che li contraddistingue. La fanno da padrone le melodie nostalgiche ma disturbanti alla Hole e qualche guizzo rabbioso che sfocia nel rock-metal(come Parasitee Micro Aggression). Oggi, Caramel supera questa malinconia in onore di una maggiore consapevolezza e un senso di unità, per un album che sa bene quando accelerare e quando guardarsi dentro, senza troppa fretta di scappare alla prossima traccia.
Insomma, una resa dei conti, dopo lo stallo pandemico che li ha visti uscire con diversi EP ancora acerbi e che si risolve in Caramel con un suono a cui si fa presto ad abituarsi. Un’abitudine non data da una pigrizia narrativa e musicale dei nostri, sia chiaro: già con Do It For Love si gioca con la ripetizione estenuante del ritornello, arricchendola di suoni ed effetti elettronici qua e là che non risultano per niente scontati. Il tutto arricchito da un testo che pare una storia d’amore, ma che sembra più un inno al sacrificio e alle conseguenze del duro lavoro. Girls! è invece un urlo all’unicità, al divertimento condiviso, rievocato dall’urlo di Jess Eastwood (frontwoman) che invoca una potenza apparentemente femminile («where the fuck are my girls!») ma che invece raggruppa tutti, indipendentemente dal genere. Le influenze dei primi Queens of The Stone Age sono forti non solo in questa traccia ma anche in Georginae Control, ambedue canzoni che parlano di donne e uomini decisi a riavvolgere il nastro per recuperare la parte migliore di sé, ormai andata perduta: Georgina viaggia sulle note malinconiche alla Pixies, differenziandosi insieme a Still Hurts, che attinge un po’ al repertorio shoegaze per la chitarra ripetitiva e piagnucolona, ma che non stufa mai; Control sfocia a metà canzone nello stoner, guadagnandosi il titolo di miglior canzone dell’album. C’è più vita e voglia di vivere in Disco Dream, unico feat pop-rock insieme a Izzy Baxter Phillips, cantante e chitarrista dei Black Honey. Forse meno convincenti le tracce leggermente pop, che fanno l’occhiolino ai riflettori dell’industria mainstream, come I Really like youe Fake It, ma che nel flusso delle tracce si amalgamano bene alle altre, rendendole un passaggio di genere per niente scontato.
In Caramel si riconosce una band che non ha ancora preso del tutto la sua forma, ma che è capace di creare un progetto originale e vendibile. Allo stesso tempo, anche nelle tracce più commerciali, si sente la necessità di sacrificare una fetta di consenso del pubblico pur di appagare la piccola community di ascoltatori che sono riusciti a creare. L’album è per certi versi un pugno allo stomaco: in realtà nasconde una profonda necessità di capire e unire, di mescolare generi per creare un unico suono coraggioso e che soprattutto distrugga la solitudine. I Coach Party cercano i loro propri ascoltatori, li avvinghiano a sé senza concedere alla pigrizia e alla frettolosità dell’ascoltatore (tipici di questi tempi) di distrarsi con qualcos’altro. Come un amalgama dolce che ti avvinghia e ti coccola, e forse un po’ ti scuote.