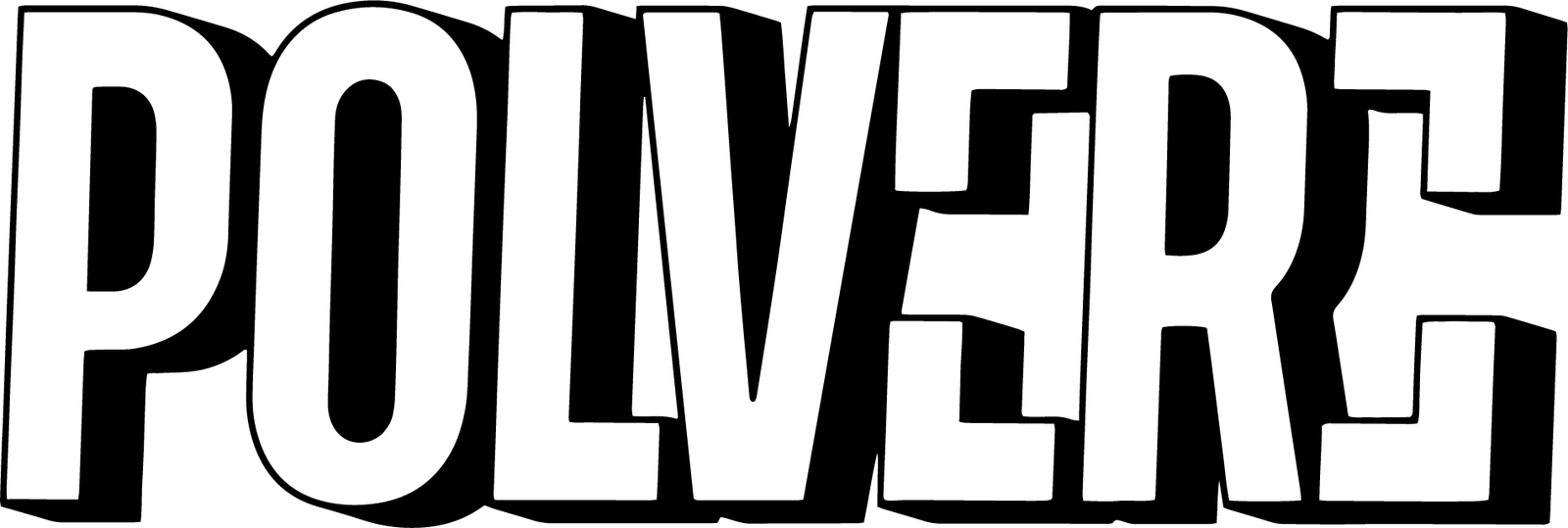Sei musicisti rifugiati al fioco lume di una lanterna. Fuori tuona il temporale: si sente il vento lacerare l’aria, la pioggia infrangersi sulle finestre. Siamo al sicuro, con loro, nel silenzio di un teatro spoglio. La scenografia è minimale ma funzionale, necessaria: l’assenza di cose da fare ci costringe all’introspezione, l’introspezione ci conduce ai ricordi. E il ricordare, inevitabilmente, alle emozioni, nel loro ampio spettro.
Eugenio Rodondi presenta così Gelicidio – il suo quarto e ultimo lavoro discografico –, portando la musica a teatro, ma anche il teatro in musica. E il teatro, si sa, è prima di tutto letteratura. La narrazione in versi a rime incrociate; la tempesta come prologo e cornice, che riporta alla mente l’inizio dell’Eneide; il richiamo a Huracán, implacabile divinità della mitologia Maya, capace di generare tempeste e uragani: molti sono gli elementi che rimandano alla tradizione della narrativa epica.
Ma non solo. La presenza di una cornice che costringe i personaggi – tramutati in narratori – in un luogo circoscritto, inducendoli a ingannare il tempo coltivando l’arte del racconto – questa volta attraverso le canzoni –, ricorda molto l’architettura del Decameron. Del resto, la tempesta come topos letterario iniziale – o comunque cruciale, in quanto punto di snodo nella trama –, è una costante non solo tra le novelle del Boccaccio, ma in gran parte della letteratura medievale.

La sala è buia e il pubblico attende in silenzio, seduto sugli spalti d’un teatro di città. Una voce solenne ne raccoglie l’attenzione: mentre parla, Il buio amplifica l’ascolto, converge l’attenzione sulle sue parole. Ben presto ci si accorge, infatti, che – al pari della luce – l’oscurità ha un ruolo importante non solo nella scenografia, ma in tutta la sceneggiatura. Così, quando Eugenio accende la sua timida lanterna, abbiamo i primi riferimenti visivi: un uomo in impermeabile giallo disteso sul pavimento; cinque musicisti, sbiaditi, fuori dal raggio del suo riflettore; qualche tenda che ricopre maldestra l’intonaco grigio delle pareti intorno. L’ambientazione scarna, del resto, è perfettamente in accordo con l’incipit iniziale: possiamo chiamare questo teatro un rifugio.
Con la sua luce, Eugenio comanda lo sguardo dello spettatore, come un custode dei nostri futuri ricordi: decide cosa vediamo, nasconde ciò che ci è chiesto soltanto di immaginare. Ed è il ricordo, per l’appunto, il filo conduttore delle sue canzoni. Ma tra i ricordi il clima è teso: la tempesta fuori dal teatro, se trasposta su un piano allegorico, sembra metafora dei turbamenti – psicologici ed emotivi – che imperversano su tutti noi, ansiosi di distrarci per non affrontarli. Eppure, prima o poi, ci si trova costretti, dal buio e dalle circostanze, a fare i conti con le insicurezze. Con le fragilità, con le paure e coi rimorsi.
Ma ogni tempesta, per quanto impervia e duratura, ha il suo cessare nella luce, nel chiarore di un mattino soleggiato. Gli uccelli cinguettano dalla finestra, il sole è un canto di sirena. Certo, i ricordi stanno lì e il dolore non scompare, ma conoscerli – e conoscersi – è la chiave che ci serve: per uscire dal rifugio, dopo il temporale.