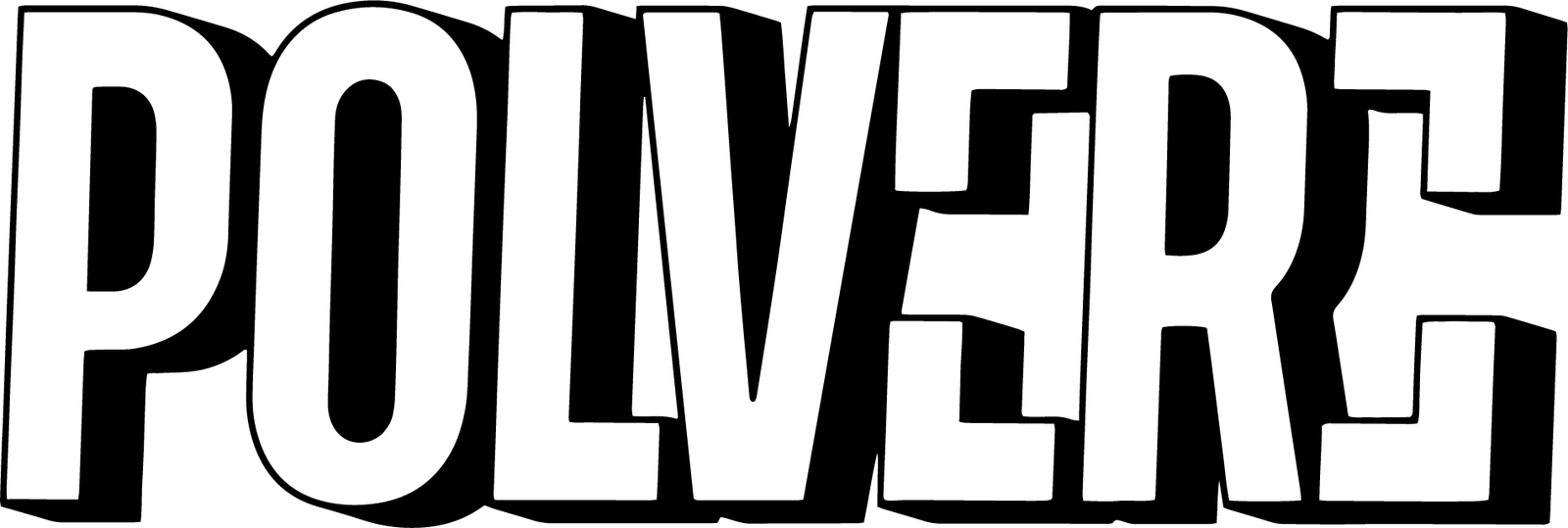Nella vita di ognuno di noi c’è un qui e ora: per alcuni dura un attimo, per altri si protrae in un continuum temporale quasi estatico. Nel caso di Alessandro Rebesani, in arte RBSN, e del suo ultimo album Here, il qui e ora è materia liquida, plasmabile, che l’artista trasmette a ognuno di noi attraverso la sua musica, facendo sì che d’un tratto, quasi inavvertitamente, l’ascolto dell’album diventi un’esperienza immersiva.
Lo abbiamo incontrato per parlare di musica, di nodi alla gola e della fine dei vent’anni.

L’album inizia con il brano This Life, connubio di molte influenze: cantautorato, folk, jazz e loop sintetici. Come ti rappresenta in questo momento della tua vita?
Questo brano rappresenta un dialogo interiore, è una parte dell’anima che dice all’altra parte dell’anima «mi sa che non ci capiscono». Solo che l’altra parte dell’anima non ha mai risposto. Ho cercato di trasmettere al contempo messaggi di smarrimento e capacità di restare fermi nelle proprie convinzioni.
Quanto è importante per te la ricerca sonora nella composizione? E quanto conta il rapporto con gli altri musicisti?
La ricerca non finisce mai! Credo sia omogenea in tutto il lavoro, in una fase iniziale prevale la trascrizione ed è fondamentale avere l’empatia necessaria per assorbire nuova musica insieme. Poi in studio la ricerca si traduce in suono, è bellissimo e anche difficile da spiegare. È dove fai le sperimentazioni più belle, quelle che finiscono nei dischi.
Le persone che hai incontrato nella tua vita e il rapporto con chi ti circonda influenzano la tua musica? Se sì, come?
Gli incontri influenzano moltissimo la narrazione che costruisco quando scrivo di eventi realmente accaduti, anche se li rielaboro per renderli più interessanti dal punto di vista narrativo. Ovviamente le circostanze e i contesti dove ho vissuto e lavorato mi hanno fatto capire molte cose ma il percorso personale forse ha più a che fare con il “perché” piuttosto che con il “dove”.
È con la condivisione che si possono fare delle cose davvero importanti, ma non è una cosa facile da instradare: è dove risiede la spiritualità della musica, nel riunirsi e suonare, un rituale.
A tal proposito, il brano The Bear è carico di simbolismi e racconta una storia: ce ne vuoi parlare?
E’ un grande racconto sull’amicizia in tutte le sue sfaccettature, sia quando sfocia in maniera romantica sia quando invece è una cosa molto profonda che rasenta la fratellanza. The Bear sono io che scelgo di chiudermi invece di comunicare e sei tu ascoltatore “amico” che ti ricordi che quella volta hai detto una parola sbagliata. Ed è anche un grande testamento emotivo, spiega molto bene i miei principi e il modo in cui uso la voce, come parte della mia identità.
«You’re the witness to rain , brother and father to some»
Qual è il tuo Here in questo momento della tua vita? È forse un luogo, delle persone o una sensazione?
Oggi è la perenne sensazione di essere sulla strada giusta, nonostante non si veda nessun sentiero, nessuna luce.
Tra il tuo primo album e il secondo cambiano le sonorità, anche se rimane ben chiara la tua identità. Tra il primo e il secondo disco è cambiato il sentimento che guida la produzione dell’album?
Credo sia maturato moltissimo e sia nata anche una selettività che viene dalla fine dei vent’anni. L’unica cosa che sono certo di avere è un’identità, per quanto riguarda le sonorità, invece, sono stato immerso in moltissimi ascolti che hanno fatto sì che in studio riuscissimo a prendere delle scelte perentorie in maniera molto rapida. Scolpire un suono, qualcosa di molto preciso.

Il disco si muove tra molte atmosfere, sia tra i brani che all’interno degli stessi. È stato pensato come un flusso continuo o come una raccolta di stanze separate?
Sono decisamente delle stanze separate, per quanto facciano tutte parte della stessa mappa.
C’è un concetto alla base dell’album?
Collegandomi alla domanda di prima, sì, in realtà è venuto man mano formandosi ma i simboli della strada, del sentiero, della mappa, del deserto, tornano in continuazione. Se volessimo riassumerlo in un percorso che inizia da un luogo di smarrimento e finisce in un luogo di unione e speranza, potremmo farlo, ma è un arco narrativo molto inflazionato, quindi ti spiego meglio:
credo che questo disco vada per step e solo chi davvero vuole appoggiarci l’orecchio sopra può arrivare fino alla fine del viaggio.
Dobbiamo ringraziare Luca Gaudenzi – che è molto bravo a fare le tracklist – e il fatto che nel mese di agosto, quando il disco stava quasi per andare in stampa, abbiamo capito che il lato A era destinato a qualcosa di più orizzontale e immediato, mentre il lato B aveva un’introspezione molto più profonda che infatti chiude il disco in maniera serena, il che spero sia il frutto di tutte le introspezioni future.
Quanto ti interessa lasciare delle zone d’ombra per chi ascolta? E qual è il ruolo del silenzio nella scrittura di questo disco?
Credo che l’interpretazione delle canzoni di tutta la storia dell’umanità sia necessariamente una responsabilità dell’ascoltatore (forse ho spiegato anche troppe cose dei brani). Il silenzio è prezioso e il cantautorato è formato da zone d’ombra, da quanto tu lasci intendere all’ascoltatore di modo che lui possa interessarsi non solo alla tua poetica, ma anche al luogo da cui proviene. Però devi essere un bravo mago, altrimenti gli spells non funzionano.
Sei riuscito a coniugare sorprendentemente fragilità e ruvidità. Nell’ascolto dell’album si percepisce un’ombra di dolore: questo sentimento è stato un motore creativo o, viceversa, l’album è stato uno strumento di elaborazione?
Non credo che il dolore sia un motore creativo in nessuna istanza quanto piuttosto un luogo in cui svegliarsi, e l’energia da scrollarsi di dosso quotidianamente è ciò che ne consegue. Quindi, per i più fortunati di noi, c’è una grande voglia di ricominciare e magari distillare l’ispirazione che ci ha dato la possibilità di ripartire, metterla dentro un nuovo lavoro e dare la possibilità ad altri di sbrogliare i loro nodi alla gola e, come dici tu, uno strumento per elaborare.
Questo disco sembra scritto più per desiderio che per necessità. A che punto fare musica smette di essere un’urgenza e diventa una possibilità di espressione libera?
Sono convinto invece che questo disco nasca da una profondissima necessità, tuttavia è importante lavorare sul messaggio e dedicarsi al lavoro e alla sua estetica; è bellissimo scrivere una canzone in cinque minuti, ma lo è anche arrangiare per tre giorni un brano e sentire i pianeti che si allineano. Per me la musica o il modo in cui scrivo non è mai stato un vezzo, non ricorro all’inglese per moda, ma perché è l’unica lingua che so usare. Non faccio musica per divertirmi, ma perché non posso fare altrimenti. Le possibilità e la struttura sono subentrate con una ripetizione ossessiva del lavoro nel corso degli anni che ha fatto sì che si creasse un gruppo attorno a un luogo specifico e soprattutto alla ricerca di un suono. Le possibilità di espressione si aprono dunque quando c’è comunicazione tra le parti e si ha chiaro qual è il suono da scolpire.

Al contempo l’album sembra rifiutare l’idea di intrattenere. Pensi che oggi fare musica significhi anche decidere chi escludere?
Dal mio punto di vista la musica è l’opposto dell’esclusione e non credo che ci siano linguaggi creati per escludere qualcuno, a meno che non si parli di codici. Certo è che ora la linea che separa l’intrattenimento dalla musica è molto sottile e quindi più che escludere qualcuno bisogna scegliere da che parte stare. Molti brani evocano immagini oltre i suoni.
Ricordi un’immagine iniziale che ha acceso l’intero progetto?
Ottima domanda, sì assolutamente. Ci sono due “foto” che ho in mente; Spiritualized: fluttuare 5 cm da terra, Here: il flair segnalazione che ora è nel visual.
Come nasce Odd Clique? Ti va di parlarci del progetto?
E’ un progetto bellissimo nato dall’urgenza e dalla necessità di avere un posto in cui trovarsi per ascoltare della musica non pensata per intrattenere, ma per mettere insieme delle persone di talento. Insomma per offrire la possibilità di vedere un futuro fatto di dischi indipendenti con un disegno in mente, cioè smettere di avere la musica italiana ghettizzata e riuscire a portarla ovunque nel mondo.
A proposito, ora che stai portando il disco in giro per l’Italia, tra sessioni di ascolto e teatri, cosa speri che rimanga dopo il primo ascolto?
Sono molto contento di dirti che questa è l’esperienza live più intensa che io e i miei collaboratori abbiamo avuto finora. L’attenzione era meravigliosa, l’affluenza sentitissima e i complimenti commoventi. Devo dire che non posso chiedere di più. Mi sembra che dopo il primo ascolto sia rimasto uno strano mix tra commozione, ispirazione e felicità. Spero anche un po’ di paura.