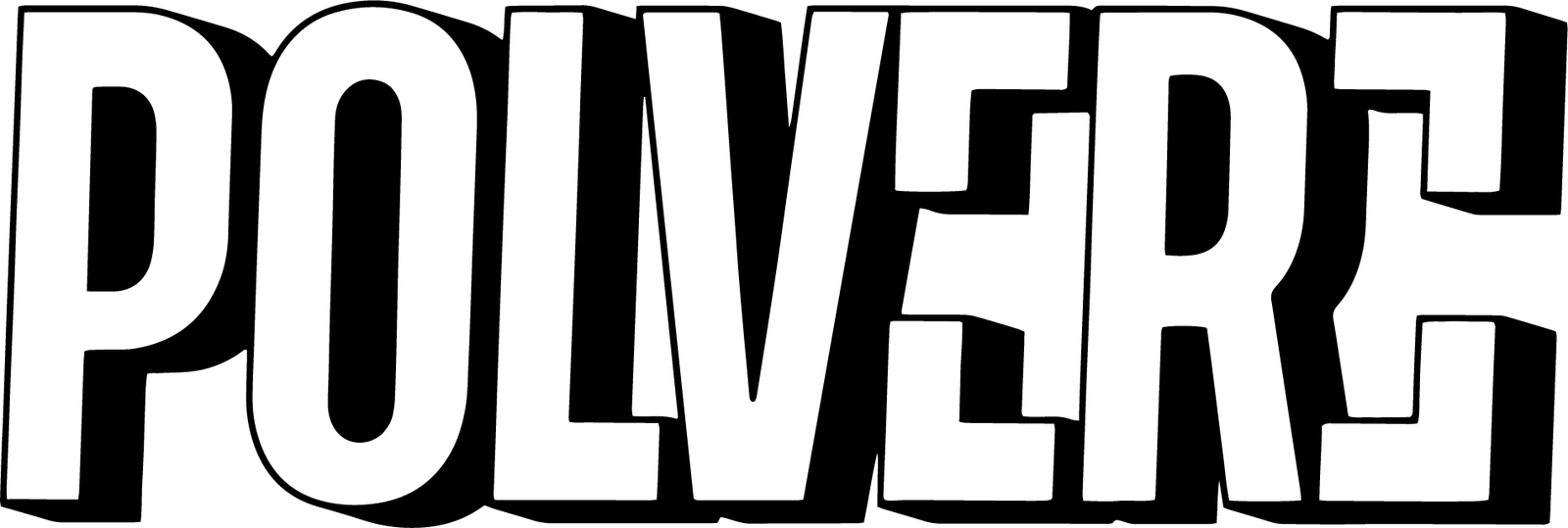Boy band members do not go to Glastonbury, questa è la legge. Robbie Williams fa il contrario: ci va. È il 1995, si presenta coi capelli ossigenati, tuta Adidas rossa, un dente pitturato di nero, sbronzo e fattissimo. Headliner del festival sono gli Oasis, con cui diventa subito amico e con cui andrà alle feste per un po’. In quel periodo sta lasciando i Take That: i rapporti con Gary Barlow sono ormai rotti anche se l’ufficialità del divorzio non c’è ancora. Il ribelle della boy band più famosa del mondo è intenzionato a iniziare una carriera solista, con canzoni sue. Quel giorno profana il tempio del rock perché lui stesso si sente rock, e vuol fare musica con una band, alzare i volumi e scuotere le folle come quelli che vede sul palco. Un fotografo col pass backstage, Mick Hutson, lo riconosce e scatta una foto del suo ghigno da bad boy: trent’anni dopo questa immagine va nella copertina dell’album che battezza Britpop, e che omaggia quegli anni matti, irripetibili e unici.
Negli anni ’90 la musica era a compartimenti stagni, se ascoltavi il rock allora schifavi ciò che appariva più morbido, radiofonico, commerciale. Il rockismo vigente vietava assolutamente di considerare le boy band alla Take That come musica degna di nota. Ti bastava vedere mezzo minuto di video su MTV per capire verso quale tipo di immagine spingeva un artista e giudicarlo di conseguenza. Robbie Williams era un po’ un irregolare, si collocava in un purgatorio di mezzo che guardava a stile e contenuti rock, pur facendo leva sul suo carisma da maschio alfa esteticamente figo. È arrivato a tanto così dall’essere davvero universale; l’avvento dell’era del poptimism avrebbe completamente sdoganato quelli come lui, ma all’epoca era ancora marchiato, troppo pop anche per i fan del britpop. Poco importa se, in gran segreto, le sue canzoni piacessero un po’ a tutti.
Per riassumere gli esordi dell’ex-Take That in cinque righe: Robbie Williams solista scalda i motori nel momento in cui il britpop lentamente si spegne. Molti pezzi attingono ancora alle sonorità ricche di chitarre e ritornelli melodici: Old Before I Die, Lazy Days, South Of The Border. Arriveranno in seguito le più famose Strong, Let Me Entertain You e ballate come Angels. Negli anni il Nostro imbocca mille strade, vuole fare lo swing, poi torna al pop, poi si reinventa crooner di Natale, attraversa pure il periodo elettronico, ma resta il fatto che buona parte delle sue canzoni più rappresentative risalgono a quei tardi anni ’90/inizio 2000.

Arriviamo a oggi. Il 2025 è stato l’anno supremo del revival britpop, con la reunion degli Oasis, il mega tour con Richard Ashcroft, i nuovi album dei Pulp e degli Suede. In quest’onda anomala Robbie Williams si tuffa senza pensarci due volte: registra un album che chiama lapalissianamente Britpop, lo anticipa con un tour europeo durato tutta l’estate, programma il release per il 10 ottobre, lo rimanda al 6 febbraio 2026 per non incorrere nella concorrenza del nuovo di Taylor Swift, cambia idea e senza preavviso lo fa uscire il 16 gennaio. Comunque molti singoli sono già usciti e l’album è una novità soltanto per 6 pezzi su 11 tracce.
La copertina mostra la famosa foto di cui sopra incorniciata in un museo, con simil-attivisti contro il pop che la imbrattano con vernice colorata. Britpop si legge bello chiaro con un font che sembra proprio quello di Parachutes, il primo album dei Coldplay. I Coldplay ci sono veramente perché Chris Martin suona in Human. E ascoltando il brano Spies non si può ignorare che si chiama come una canzone dei londinesi e ha un incedere che ricorda la Yellow cantata sulla spiaggia del famoso video del 2000. Tra gli autori dell’album c’è Gaz Coombes dei Supergrass che co-firma Cocky. E soprattutto colpisce la presenza di Gary Barlow, il “prescelto” della boy band e rivale, che scrive insieme a Robbie un brano che si chiama Morrissey ed è una dedica a un artista che del britpop è stato ziastro controverso e imprevedibile. La chitarra di Tony Iommi in Rocket è un’eccezione al tema ma è abbastanza esaltante; il featuring con il duo messicano Jesse & Joy è l’unico momento di cui si capisce poco il senso.
È un disco di maniera composto proprio come era la moda dell’epoca: abbondanti schitarrate aperte, parti orchestrali pompose, ritornelli catchy al primo colpo. «Volevo creare l’album che avrei voluto scrivere e pubblicare dopo aver lasciato i Take That nel 1995», ha detto. Gli autori principali sono Karl Brazil con Tom Longworth e vari collaboratori. Tra le paure e la voglia di mettersi a nudo sul palco, tra sostanze stupefacenti e paranoie sulle quali già si era aperto nel film biografico Better Man, rimane il ragazzo che non si è mai ammorbidito, che continua a lottare contro i suoi demoni ma anche a farci l’amore; il signor Robert Peter Williams è sempre Robbie.
Anche se l’unico britpop che ha la possibilità di rimanere rappresentativo dell’epoca attuale è l’album di A.G. Cook, questo di Robbie Williams è comunque un gradevole disco di genere, mai noioso, a tratti divertente, con qualche stucchevolezza melodica che un tempo funzionava e oggi è un po’ cliché, ma anche con qualche stuzzicheria data dagli ospiti nominati. È un’iniziativa ispirata al revival che non cambierà di una virgola la sua carriera, né l’epica consolidata della Cool Britannia, tantomeno la storia della musica, ma fa capire, trent’anni dopo, da dove viene l’artista di Stoke-on-Trent. La sua voce nasale e spaccona sembra essere nata per sovrastare colate di chitarre e raccontarsi tra talento e sregolatezza come una magia in area di rigore di Gazza Gascoigne. La musica con la quale si è liberato, che gli ha acceso la scintilla che l’ha portato a scrivere da sé la sua storia, è quella che ha interpretato nell’album appena uscito. Il giorno in cui gli scattavano quella foto, strafatto, ossigenato e senza un dente, è stata realmente una svolta della sua carriera. Oggi, nel momento più britpop di sempre dopo gli anni ’90, l’album più celebrativo dell’epoca è il suo.