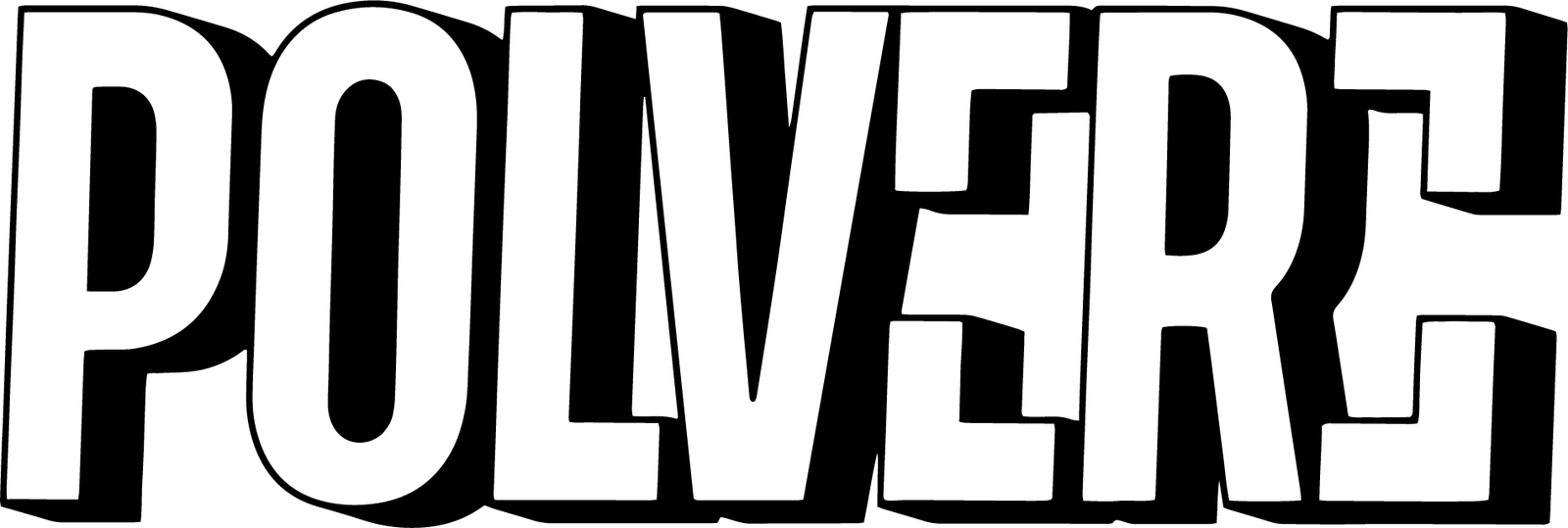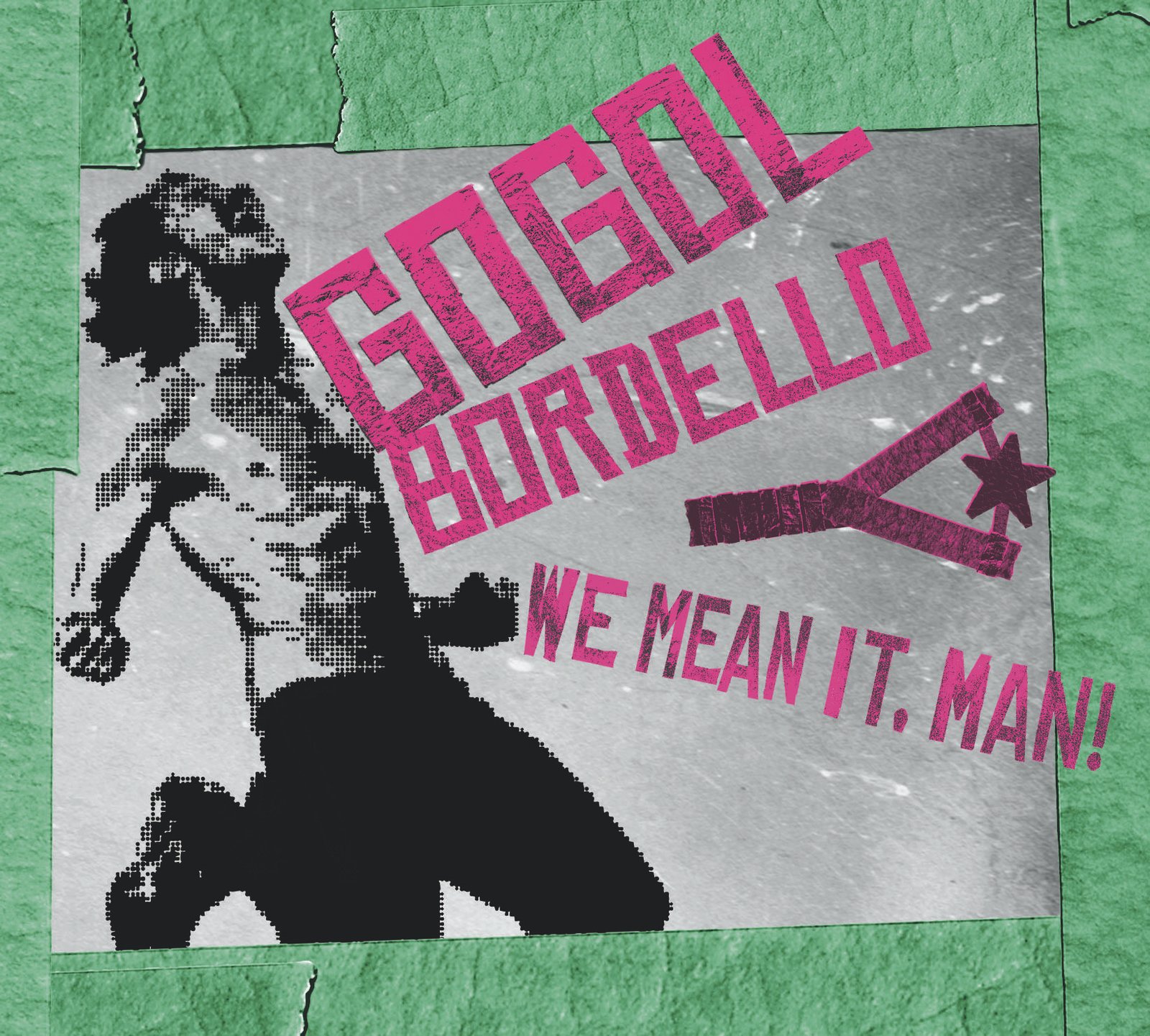Ci sono formule di successo che sembrano destinate a restare immortali nel tempo e a rinnovarsi continuamente senza perdere la propria identità e la propria forza. E quando, soprattutto nel panorama musicale, arriva una metamorfosi improvvisa, il risultato lascia – nella stragrande maggioranza dei casi – l’amaro in bocca. Ma ci sono band che, quando scelgono di reinventarsi, non lo possono fare con mezze misure, né in modo banale: è il caso dei Gogol Bordello, che con il nuovo album We Mean It, Man! stupiscono il mondo attraverso la propria personalissima “vendetta post-punk”.
Il disco, uscito lo scorso 13 febbraio per l’etichetta Casa Gogol di proprietà di Eugene Hutz, unisce al caos euforico e travolgente del gypsy punk diverse e inaspettate contaminazioni: oltre al già citato post-punk, rivendicato a gran voce dal frontman come principale influenza musicale, spiccano gli elementi più disparati come hardcore punk, elettronica, techno e orchestrale. La metamorfosi è stata possibile anche e soprattutto grazie a una produzione d’eccezione, affidata a Nick Launay (all’opera con Idles, Nick Cave and The Bad Seeds, Public Image Limited, Gang Of Four, Yeah Yeah Yeahs) e ad Adam “Atom” Greenspan (Nick Cave, Idles, Refused, Amyl and The Sniffers).
Il nuovo sound dei Gogol Bordello, quindi, non è più definito solamente dal ritmo incalzante di batterie e percussioni sudate e forsennate, o dai virtuosismi gitani di violino, fisarmonica e fiati, ma anche da graffianti riff di chitarra, beat elettronici e synth che si insinuano in modo equilibrato, non sovrastando la classica impostazione migrante, piuttosto rinnovandola in modo molto efficace. Il risultato? Una visione sonora molto più complessa e stratificata che unisce i puntini tra epoche, immaginari e vibrazioni. Dal punto di vista tematico, invece, non sussistono particolari novità rispetto al passato: l’attenzione verso le tematiche di stretta attualità sociale e politica, soprattutto legata agli scenari di guerra (Ucraina, per ragioni territoriali, in primis) resta altissima, confermando la band come voce degli outsider.

We Mean It, Man! si apre con la title track, che canta e suona come una vera e propria dichiarazione di intenti, quasi un manifesto politico programmatico: i Gogol Bordello fanno sul serio, lo gridano in modo sfacciato e invitano l’umanità a resistere e a prendersi cura di se stessa in un mondo sanguinante («Brothers are played against one another / While sisters continue to bleed / There is no center, there is no vector / There is no anchor at all / Clock it one time, wise up / Once again»). La successiva Life Is Possibile Again porta invece l’ascoltatore su binari sonori sinfonici, dominati dal violino, introducendo un elemento che non è mai mancato nella discografia della band: la speranza, nonostante tutto («Just when you think you’ve heard it all / And saw it all right through (…) In such an angle, such a way / That life is possible again»).
In mezzo a questo marasma umano e spirituale, anche i Gogol Bordello si trovano – loro malgrado – ad avere a che fare con tutta la marmaglia di personaggi discutibili che popola la terra in questi tempi difficili: è questo il focus di No Time for Idiots che, a metà tra frustrazione sociale e critica lucida, rivendica in modo punk l’impegno politico come spinta verso un futuro migliore («You might be Socrates / Or you might be Confucius / But don’t forget about a moron / Always lurking in the bushes»). Sulla stessa lunghezza d’onda è Hater Liquidator, vera e propria invettiva contro gli odiatori seriali («War, pandemic, what else do you need / To see who’s made out of what, who’s got busted creed»), in cui entrano prepotentemente in gioco gli elementi elettronici citati in apertura grazie a un groove da dancefloor che non sfigurerà – ne siamo certi – nemmeno nei contesti live tanto cari a Eugene e compagni.
Tutte le contaminazioni di We Mean It, Man! trovano pienamente sfogo nella parte centrale dell’album: Boiling Point apre le porte alle collaborazioni, in questo caso con la cantautrice newyorkese Grace Bergere, con una patchanka di generi più intima e melodica. Le successive Ignition, From Boyarka to Boyaca (ponte immaginario tra Ucraina e Colombia insieme alla band Puzzled Panther, di cui fa parte lo stesso Hutz) e Mystycs, invece, fanno saltare dalla sedia, trascinando tutti e tutte in pista grazie a un mix irresistibile e inesorabile di punk, dance e techno in contrasto con la natura più introspettiva dei testi, con chitarre e synth a farla da padrone.
La tensione, sia lirica che sonora, resta alta anche verso la chiusura: a fare da apripista è la brevissima e intensa Crayons, ruvida esplosione di energia pop punk. Si tratta di un più che adeguato prologo al gran finale, contraddistinto da due canzoni che riassumono le opposte sensazioni che emergono dall’ascolto dell’intero album: State of Shock, apoteosi dell’ansia e dell’incertezza della vita nella società della belligeranza e della performance contemporanea («Wandering in caverns of doubt / Afraid to find reasons to banquet / Sure, one can hide, but there’s a world outside / Shall be safe under a fireproof blanket»), e Solidarity, grido sofferente dedicato alla popolazione ucraina («We are with you in our hearts and in our minds / And we’ll pray for a nation through its darkest time»); a suggellare la vendetta post-punk perfetta è un musicista che quella scena ha contribuito a crearla in modo immortale: il chitarrista di Joy Division e New Order Bernard Sumner (con mix di Nick Launay).

Con We Mean It, Man!, i Gogol Bordello non si limitano a cambiare pelle, ma compiono un gesto ancora più incisivo: scelgono di esporsi e di rischiare, ridefinendo i propri orizzonti sonori senza smarrire la propria identità nomade e militante. Siamo di fronte a una metamorfosi che non rinnega il passato ma lo attraversa, lo mette in tensione, lo elettrifica ancora di più. La “vendetta post punk” evocata da Eugene Hutz non è un semplice vezzo stilistico, bensì un atto politico ed estetico: un modo per riaffermare che l’urgenza espressiva può e deve trovare nuove forme per restare viva.
In un’epoca in cui molte band storiche si adagiano sulla nostalgia e molte svolte si rivelano esercizi di maniera, questo album suona come una dichiarazione di vitalità. La produzione incornicia e potenzia una band che sembra aver trovato una nuova grammatica per raccontare lo stesso mondo ferito di sempre: più stratificata e più scura, certo, ma anche più consapevole. Il risultato è un disco che vibra di rabbia e speranza, ansia e solidarietà, e che trova un ponte ideale tra genealogie musicali e nuove traiettorie migranti.
We Mean It, Man! non è soltanto il capitolo più riuscito dei Gogol Bordello negli ultimi anni: è la prova che, quando una band crede davvero nella propria evoluzione, può trasformare il cambiamento in un atto di resistenza culturale. E farlo suonare necessario.