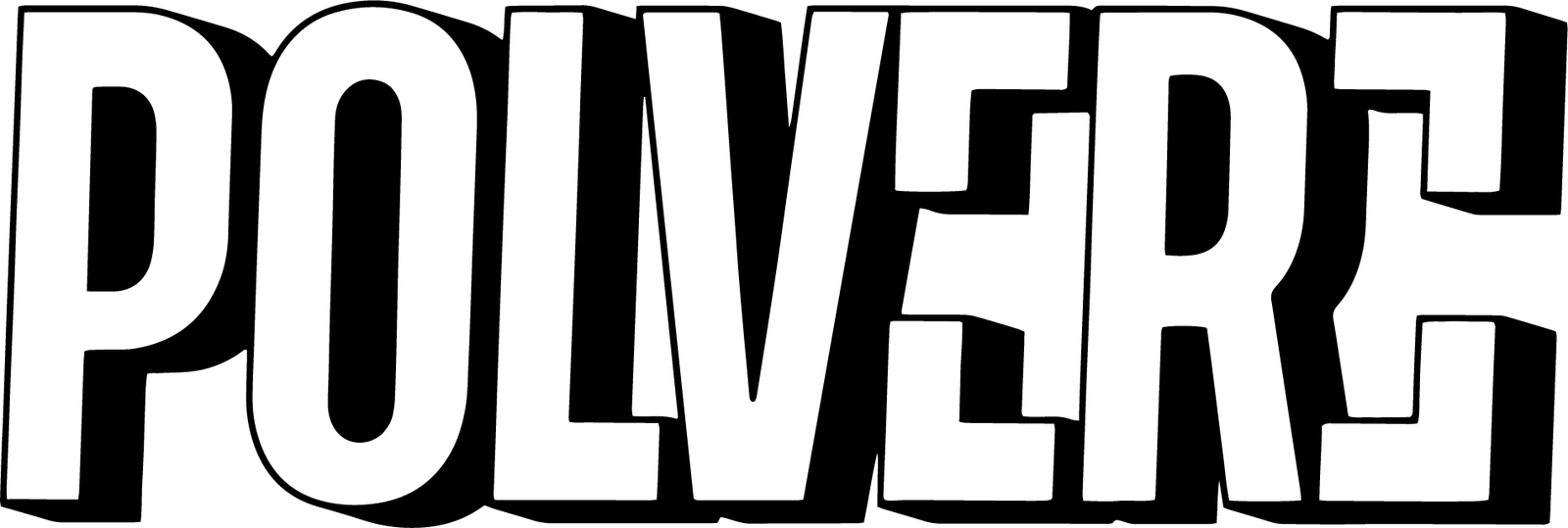Per chi non li conoscesse (o non se li ricordasse), i Cults furono una specie di fenomeno del web, una decina di anni fa: un piccolo EP spopolato su Bandcamp e l’anno dopo un contratto discografico con la Columbia. Era il 2011, e il loro omonimo album d’esordio avrebbe avuto un successo inspiegabile, in quanto si trattava di un lavoro che già all’epoca era decisamente derivativo; un indie/dream pop dal sapore lo-fi, tirato su dal polistrumentista Brian Oblivion, fuso con la voce eterea e sognante di Madeline Follin, la quale, con un passato nel punk, sapeva struggere e incantare allo stesso tempo. Dunque un disco accattivante e abbastanza divertente, seppur non particolarmente originale neanche per l’epoca.
Con i lavori successivi la band iniziò a incupirsi sempre di più, nelle sonorità e nei testi, pur mantenendo quell’atmosfera sognante e quell’attitudine nostalgica. Il successo di Always Forever, dall’opera seconda Static (2013), è l’esempio di maggior rilievo. Ma Offering (2017) e Host (2020), rispettivamente terzo e quarto album, mancano di idee e risultano estremamente ripetitivi, rasentando la mediocrità. In una parola, noiosi.
A distanza di quattro anni il duo newyorkese torna con un nuovo album in studio, To the Ghosts. Rintocchi di campane compongono una melodia che si fonde con una chitarra post-punk. Così inizia l’opening Crybaby, che segna un ritorno alle origini ma dalla produzione inevitabilmente più pulita, forse troppo. Insomma, laccata. Il ritornello è catchy e l’atmosfera è quel mix contrastato di gioia e malinconia tanto caro ai Cults. L’andazzo è il medesimo nella successiva Left My Keys, dal ritornello di stampo sixties ma dannatamente stucchevole.
L’album risente dell’influenza neo-psichedelica alla Tame Impala. Da questo punto di vista, tracce come Onions risultano discretamente interessanti. Ma gli inserti più sperimentali e lisergici – che tuttavia non si avvicinano alla genialità creativa del cantautore australiano – non privano To the Ghosts della noia causata da tracce mediocri come Crystal, con quel giro di synth cartoonesco e insopportabile.
Sia chiaro, qualitativamente parlando, To the Ghosts è sicuramente un passo avanti per la band rispetto ai due dischi precedenti. Ma ad avvolgerlo è quel velato semplicismo che impedisce all’ascoltatore di appassionarsi alle canzoni, che da Leave Home alla penultima You’re In Love With Yourself passano una dopo l’altra senza che ne si ricordi una (e questo, specialmente per un disco pop, non è il massimo), tranne Behave, il cui timbro della Follin eccessivamente effettato annienta psicologicamente, e non lo si dimentica facilmente… purtroppo. Ma forse esagero, dato che tra queste tracce c’è anche Open Water, in cui i virtuosismi strumentali di Oblivion non sono niente male.
Il disco ha la fortuna di chiudersi con un brano a metà tra il semplice e il ricercato. Hung The Moon, nel suo essere la summa di tutte le influenze più caratterizzanti della band, riesce a non essere un pasticcio. Oltre 5 minuti di sperimentalismi sonori e nostalgia retrò, con la melodia di Follin che duetta con la chitarra di Oblivion; ottoni e tastiere si mescolano in un pezzo che sale e scende, abbraccia e abbandona, fino a esplodere per poi dissolversi e perdersi nel vuoto.
Un vuoto che però è lo stesso che lascia To the Ghosts, nel complesso è sufficiente, ma dimenticabile. L’ennesima dimostrazione che il fenomeno Cults, che alla fine piaccia o no, che sia piaciuto o no, è finito già da un pezzo.